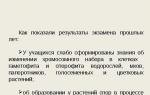Gli ossidi, la loro classificazione e proprietà sono la base di una scienza così importante come la chimica. Cominciano a essere studiati nel primo anno di studio della chimica. Nelle scienze esatte come la matematica, la fisica e la chimica, tutto il materiale è interconnesso, motivo per cui l'incapacità di padroneggiare il materiale comporta una mancanza di comprensione di nuovi argomenti. Pertanto, è molto importante comprendere il tema degli ossidi e comprenderlo appieno. Cercheremo di parlarne più in dettaglio oggi.
Cosa sono gli ossidi?
Gli ossidi, la loro classificazione e proprietà sono ciò che deve essere compreso prima. Allora, cosa sono gli ossidi? Te lo ricordi da scuola?
Gli ossidi (o ossidi) sono composti binari che contengono atomi di un elemento elettronegativo (meno elettronegativo dell'ossigeno) e ossigeno con uno stato di ossidazione -2.
Gli ossidi sono sostanze incredibilmente comuni sul nostro pianeta. Esempi di composti di ossido includono acqua, ruggine, alcuni coloranti, sabbia e persino anidride carbonica.

Formazione di ossidi
Gli ossidi possono essere ottenuti in vari modi. La formazione degli ossidi è studiata anche da una scienza come la chimica. Ossidi, loro classificazione e proprietà: questo è ciò che gli scienziati devono sapere per capire come si è formato questo o quell'ossido. Ad esempio, possono essere ottenuti combinando direttamente un atomo (o atomi) di ossigeno con un elemento chimico: questa è l'interazione degli elementi chimici. Tuttavia, esiste anche una formazione indiretta di ossidi, cioè quando gli ossidi si formano dalla decomposizione di acidi, sali o basi.

Classificazione degli ossidi
Gli ossidi e la loro classificazione dipendono da come si formano. Secondo la loro classificazione, gli ossidi sono divisi solo in due gruppi, il primo dei quali forma sale e il secondo non forma sale. Quindi, diamo uno sguardo più da vicino a entrambi i gruppi.
Gli ossidi che formano sale sono un gruppo abbastanza ampio, suddiviso in ossidi anfoteri, acidi e basici. Come risultato di qualsiasi reazione chimica, gli ossidi che formano sali formano sali. Di norma, la composizione degli ossidi che formano sali comprende elementi di metalli e non metalli, che formano acidi a seguito di una reazione chimica con l'acqua, ma quando interagiscono con le basi formano gli acidi e i sali corrispondenti.
Gli ossidi che non formano sali sono quegli ossidi che non formano sali a seguito di una reazione chimica. Esempi di tali ossidi includono il carbonio.
Ossidi anfoteri
Gli ossidi, la loro classificazione e proprietà sono concetti molto importanti in chimica. La composizione dei composti formatori di sale comprende ossidi anfoteri.
Gli ossidi anfoteri sono ossidi che possono presentare proprietà basiche o acide, a seconda delle condizioni delle reazioni chimiche (presentano anfotericità). Si formano tali ossidi (rame, argento, oro, ferro, rutenio, tungsteno, rutherfordio, titanio, ittrio e molti altri). Gli ossidi anfoteri reagiscono con acidi forti e, come risultato di una reazione chimica, formano sali di questi acidi.

Ossidi acidi
Oppure le anidridi sono ossidi che esibiscono e formano anche acidi contenenti ossigeno nelle reazioni chimiche. Le anidridi sono sempre formate da tipici non metalli, nonché da alcuni elementi chimici di transizione.
Gli ossidi, la loro classificazione e le proprietà chimiche sono concetti importanti. Ad esempio, gli ossidi acidi hanno proprietà chimiche completamente diverse dagli ossidi anfoteri. Ad esempio, quando un'anidride reagisce con l'acqua, si forma un acido corrispondente (l'eccezione è SiO2 - Le anidridi reagiscono con gli alcali e come risultato di tali reazioni vengono rilasciate acqua e soda. Quando reagiscono con, si forma un sale.

Ossidi basici
Gli ossidi basici (dalla parola "base") sono ossidi di elementi chimici di metalli con stati di ossidazione +1 o +2. Questi includono metalli alcalini e alcalino terrosi, nonché l'elemento chimico magnesio. Gli ossidi basici differiscono dagli altri in quanto sono quelli in grado di reagire con gli acidi.
Gli ossidi basici interagiscono con gli acidi, a differenza degli ossidi acidi, nonché con gli alcali, l'acqua e altri ossidi. Come risultato di queste reazioni, di solito si formano sali.

Proprietà degli ossidi
Se studi attentamente le reazioni di vari ossidi, puoi trarre conclusioni in modo indipendente su quali proprietà chimiche sono dotate degli ossidi. La proprietà chimica comune di assolutamente tutti gli ossidi è il processo redox.
Tuttavia, tutti gli ossidi sono diversi l'uno dall'altro. La classificazione e le proprietà degli ossidi sono due argomenti correlati.
Ossidi non salini e loro proprietà chimiche
Gli ossidi che non formano sali sono un gruppo di ossidi che non presentano proprietà né acide, basiche né anfotere. Come risultato delle reazioni chimiche con ossidi non salini, non si formano sali. In precedenza, tali ossidi non erano chiamati non salini, ma indifferenti e indifferenti, ma tali nomi non corrispondono alle proprietà degli ossidi non salini. Secondo le loro proprietà, questi ossidi sono abbastanza capaci di reazioni chimiche. Ma ci sono pochissimi ossidi che non formano sali; sono formati da non metalli monovalenti e bivalenti.
Dagli ossidi non salini si possono ottenere ossidi salini come risultato di una reazione chimica.

Nomenclatura
Quasi tutti gli ossidi vengono solitamente chiamati così: la parola “ossido”, seguita dal nome dell'elemento chimico al caso genitivo. Ad esempio, Al2O3 è ossido di alluminio. Nel linguaggio chimico questo ossido si legge così: alluminio 2 o 3. Alcuni elementi chimici, come il rame, possono avere diversi gradi di ossidazione, di conseguenza anche gli ossidi saranno diversi. Quindi l'ossido di CuO è ossido di rame (due), cioè con un grado di ossidazione di 2, e l'ossido di Cu2O è ossido di rame (tre), che ha un grado di ossidazione di 3.
Ma ci sono altri nomi per gli ossidi, che si distinguono per il numero di atomi di ossigeno nel composto. Monossidi o monossidi sono quegli ossidi che contengono un solo atomo di ossigeno. I biossidi sono quegli ossidi che contengono due atomi di ossigeno, che vengono indicati con il prefisso “di”. I triossidi sono quegli ossidi che contengono già tre atomi di ossigeno. Nomi come monossido, biossido e triossido sono già obsoleti, ma si trovano spesso nei libri di testo, nei libri e in altri sussidi.
Esistono anche i cosiddetti nomi banali per gli ossidi, cioè quelli che si sono sviluppati storicamente. Ad esempio, la CO è l'ossido o monossido di carbonio, ma anche i chimici spesso chiamano questa sostanza monossido di carbonio.

Quindi, un ossido è un composto di ossigeno con un elemento chimico. La scienza principale che studia la loro formazione e le loro interazioni è la chimica. Gli ossidi, la loro classificazione e proprietà sono alcuni argomenti importanti nella scienza della chimica, senza capire quali non è possibile capire tutto il resto. Gli ossidi sono gas, minerali e polveri. Alcuni ossidi meritano di essere conosciuti in dettaglio non solo dagli scienziati, ma anche dalla gente comune, perché possono essere pericolosi anche per la vita su questa terra. Gli ossidi sono un argomento molto interessante e abbastanza semplice. I composti di ossido sono molto comuni nella vita di tutti i giorni.
Nelle attività dell'esame di stato unificato ci sono domande in cui è necessario determinare il tipo di ossido. Innanzitutto ci sono quattro tipologie di ossidi da ricordare:
1) non salino
2) basilare
3) acido
4) anfotero
Anche gli ossidi basici, acidi e anfoteri sono spesso raggruppati insieme ossidi salini.
Senza entrare nei dettagli teorici, delineerò un algoritmo passo passo per determinare il tipo di ossido.
Primo- determinare: l'ossido metallico di fronte a voi o l'ossido non metallico.
Secondo- Dopo aver stabilito quale ossido metallico o non metallico si trova di fronte a te, determina lo stato di ossidazione dell'elemento in esso contenuto e utilizza la tabella seguente. Naturalmente le regole per l'assegnazione degli ossidi presenti in questa tabella vanno apprese. All'inizio puoi risolvere i compiti guardandolo, ma il tuo obiettivo è ricordarlo, poiché non ci sono fonti di informazione nell'esame tranne la tabella D.I. Non avrai una tavola periodica, tabelle di solubilità o serie di attività per i metalli.
|
Ossido non metallico |
Ossido di metallo |
|
1) Stato di ossidazione del non metallo +1 o +2 Conclusione: ossido che non forma sale Eccezione: Cl 2 O non è un ossido che non forma sale |
1) Lo stato di ossidazione del metallo è +1, +2 Conclusione: l'ossido di metallo è basilare Eccezione:BeO,ZnO, SnO e PbO non sono inclusiagli ossidi basici!! |
|
2) Lo stato di ossidazione è maggiore o uguale a +3 Conclusione: ossido acido Eccezione: Cl 2 O è un ossido acido, nonostante lo stato di ossidazione del cloro +1 |
2) Stato di ossidazione del metallo +3, +4, Conclusione: l'ossido è anfotero. Eccezione: BeO, ZnO, SnO e PbOanfotero, nonostante lo stato di ossidazione +2 dei metalli |
|
3) Stato di ossidazione del metallo +5,+6,+7 Conclusione: ossido acido. |
Esempi:
Esercizio: determinare il tipo di ossido di MgO.
Soluzione: MgO è un ossido metallico e lo stato di ossidazione del metallo in esso contenuto è +2. Tutti gli ossidi metallici negli stati di ossidazione +1 e +2 sono basici, ad eccezione dell'ossido di berillio o di zinco.
Risposta: MgO è l'ossido principale.
Esercizio: determinare il tipo di ossido Mn 2 O 7
Soluzione: Mn 2 O 7 è un ossido metallico e lo stato di ossidazione del metallo in questo ossido è +7. Gli ossidi metallici in stati di ossidazione elevati (+5, +6, +7) sono classificati come acidi.
Risposta: Mn 2 O 7 – ossido acido
Esercizio: determinare il tipo di ossido Cr 2 O 3.
Soluzione: Cr 2 O 3 è un ossido metallico e lo stato di ossidazione del metallo in questo ossido è +3. Gli ossidi metallici negli stati di ossidazione +3 e +4 sono classificati come anfoteri.
Risposta: Cr 2 O 3 è un ossido anfotero.
Esercizio: determinare il tipo di ossido N 2 O.
Soluzione: N 2 O è un ossido non metallico e lo stato di ossidazione del non metallo in questo ossido è +1. Gli ossidi non metallici negli stati di ossidazione +1 e +2 non formano sali.
Risposta: N 2 O è un ossido che non forma sale.
Esercizio: determinare il tipo di ossido di BeO.
Soluzione: Fanno eccezione l'ossido di berillio e l'ossido di zinco. Nonostante lo stato di ossidazione dei metalli in essi contenuti sia +2, sono anfoteri.
Risposta: BeO è un ossido anfotero.
Puoi familiarizzare con le proprietà chimiche degli ossidi
Gli ossidi sono sostanze complesse costituite da due elementi, uno dei quali è l'ossigeno nel secondo stato di ossidazione.
Nella letteratura chimica per la nomenclatura degli ossidi si seguono le seguenti regole:
- Quando si scrivono le formule, l'ossigeno viene sempre messo al secondo posto: NO, CaO.
- Quando si nominano gli ossidi, si usa sempre per prima la parola ossido, seguita dal nome del secondo elemento al caso genitivo: BaO - ossido di bario, K₂O - ossido di potassio.
- Nel caso in cui un elemento formi più ossidi, dopo il suo nome l'elemento è indicato tra parentesi, ad esempio N₂O₅ - (V), Fe₂O₃ - ossido di ferro (II), Fe₂O₃ - ossido di ferro (III).
- Quando si nominano gli ossidi più comuni, è imperativo denotare i rapporti degli atomi nella molecola con i corrispondenti numeri greci: N₂O - ossido di diazoto, NO₂ - biossido di azoto, N₂O₅ - pentossido di diazoto, NO - monossido di azoto.
- Si consiglia di denominare le anidridi allo stesso modo degli ossidi (ad esempio N₂O₅ - (V)).
Gli ossidi possono essere preparati in diversi modi:
- Interazione con l'ossigeno di sostanze semplici. Le sostanze semplici si ossidano quando riscaldate, spesso rilasciando calore e luce. Questo processo è chiamato combustione
C + O₂ = CO₂ - L'ossidazione produce ossidi di elementi che sono inclusi nella sostanza originale:
2H₂S + 3O₂ = 2 H₂O + 2 SO₂ - Decomposizione di nitrati, idrossidi, carbonati:
2Cu(NO₃)₂ = 2CuO + 4NO₂ + O₂
CaCO₃ = CaO + CO₂
Cu(OH)₂ = CuO + H₂O - Come risultato dell'ossidazione dei metalli da parte degli ossidi di altri elementi. Tali reazioni divennero la base della metallotermia: la riduzione dei metalli dai loro ossidi utilizzando metalli più attivi:
2Al + Cr₂O₃ = 2Cr ±Al₂O₃ - Per decomposizione o ossidazione aggiuntiva di inferiore:
4CrO₃ = 2Cr₂O₃ + 3O₃
4FeO + O₂ = 2Fe₂O₃
4CO + O₂ = 2CO₂
La classificazione degli ossidi in base alle loro proprietà chimiche prevede la loro suddivisione in ossidi formanti sali e ossidi non formanti sali (indifferenti). Gli ossidi che formano sale, a loro volta, sono divisi in acidi, basici e anfoteri.
Ossidi basici le basi corrispondono. Ad esempio, Na₂O, CaO, MgO sono ossidi basici, poiché corrispondono alle basi: NaOH, Ca(OH)₂, Mg(OH)₂. Alcuni ossidi (K₂O e CaO) reagiscono facilmente con l'acqua e formano le basi corrispondenti:
CaO + H₂O = Ca(OH)₂
K₂O + H₂O = 2KOH
Gli ossidi Fe₂O₃, CuO, Ag₂O non reagiscono con l'acqua, ma neutralizzano gli acidi, per cui sono considerati basici:
Fe₂O₃, + 6HCl = 2FeCl₃ + 3H₂OCuO + H₂SO₄ + H₂O
Ag₂O + 2HNO₃ = 2AgNO₃ + H₂O
Le proprietà chimiche tipiche degli ossidi di questo tipo sono la loro reazione con acidi, a seguito della quale, di norma, si formano acqua e sale:
FeO + 2HCl = FeCl₂ + H₂O
Gli ossidi basici reagiscono anche con gli ossidi acidi:
CaO + CO₂ = CaCO₃.
Ossidi acidi corrispondono agli acidi. Ad esempio, l'ossido N₂O₃ corrisponde a HNO₂, Cl₂O₇ - HClO₄, SO₃ - acido solforico H₂SO₄.
La principale proprietà chimica di tali ossidi è la loro reazione con le basi, formando sale e acqua:
2NaOH + CO₂ = NaCO₃ + H₂O
La maggior parte degli ossidi acidi reagiscono con l'acqua per formare gli acidi corrispondenti. Allo stesso tempo, l'ossido SiO₂ è praticamente insolubile in acqua, ma neutralizza le basi, quindi è un ossido acido:
2NaOH + SiO₂ = (fusione) Na₂siO₃ + H₂O
Ossidi anfoteri- si tratta di ossidi che, a seconda delle condizioni, presentano proprietà acide e basiche, cioè Quando interagiscono con gli acidi, si comportano come ossidi basici e quando interagiscono con le basi si comportano come ossidi acidi.
Non tutti gli ossidi anfoteri reagiscono nella stessa misura con basi e acidi. Alcuni hanno proprietà basiche più pronunciate, altri hanno proprietà più acide.
Se l'ossido di zinco o cromo reagisce allo stesso modo con acidi e basi, allora l'ossido Fe₂O₃ ha proprietà basiche predominanti.
Le proprietà degli ossidi anfoteri sono mostrate usando l'esempio di ZnO:
ZnO + 2HCl = ZnCl₂ + H₂O
ZnO + 2NaOH = Na₂ZnO₂ + H₂O
Gli ossidi che non formano sali non formano né acidi né basi (ad esempio N₂O, NO).
Inoltre, non danno reazioni caratteristiche degli ossidi che formano sali. Gli ossidi non salini possono reagire con acidi o alcali, ma in questo caso i prodotti caratteristici degli ossidi salini non si formano, ad esempio, a 150⁰C e 1,5 MPa, la CO reagisce con idrossido di sodio per formare un sale - formiato di sodio :
CO+NaOH = HCOONa
Gli ossidi non salini non sono così diffusi come altri tipi di ossidi e si formano principalmente con la partecipazione di non metalli bivalenti.
Ossidi.
Si tratta di sostanze complesse costituite da DUE elementi, uno dei quali è l'ossigeno. Per esempio:
CuO - ossido di rame (II).
AI2O3 – ossido di alluminio
SO 3 – ossido di zolfo (VI)
Gli ossidi sono divisi (classificati) in 4 gruppi:
Na2O – Ossido di sodio
CaO – Ossido di calcio
Fe 2 O 3 – ossido di ferro (III).
2). Acido– Questi sono ossidi non metalli. E a volte i metalli se lo stato di ossidazione del metallo è > 4. Ad esempio:
CO 2 – Monossido di carbonio (IV)
P 2 O 5 – Ossido di fosforo (V).
SO 3 – Ossido di zolfo (VI)
3). Anfotero– Questi sono ossidi che hanno le proprietà sia degli ossidi basici che di quelli acidi. È necessario conoscere i cinque ossidi anfoteri più comuni:
BeO – ossido di berillio
ZnO – Ossido di zinco
AI 2 O 3 – Ossido di alluminio
Cr 2 O 3 – Ossido di cromo (III).
Fe 2 O 3 – Ossido di ferro (III).
4). Non forma sale (indifferente)– Si tratta di ossidi che non presentano le proprietà né degli ossidi basici né di quelli acidi. Ci sono tre ossidi da ricordare:
CO – monossido di carbonio (II) monossido di carbonio
NO – ossido nitrico (II)
N 2 O – protossido di azoto (I) gas esilarante, protossido di azoto
Metodi per produrre ossidi.
1). Combustione, cioè interazione con l'ossigeno di una sostanza semplice:
4Na + O2 = 2Na2O
4P + 5O2 = 2P2O5
2). Combustione, cioè interazione con l'ossigeno di una sostanza complessa (costituita da due elementi) formandosi così due ossidi.
2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2
4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2
3). Decomposizione tre acidi deboli. Altri non si decompongono. In questo caso si formano ossido acido e acqua.
H2CO3 = H2O + CO2
H2SO3 = H2O + SO2
H2SiO3 = H2O + SiO2
4). Decomposizione insolubile motivi. Si formano un ossido basico e acqua.
Mg(OH)2 = MgO + H2O
2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O
5). Decomposizione insolubile sali Si formano un ossido basico e un ossido acido.
CaCO3 = CaO + CO2
MgSO3 = MgO + SO2
Proprietà chimiche.
IO. Ossidi basici.
alcali.
Na2O + H2O = 2NaOH
CaO + H2O = Ca(OH)2
СuO + H 2 O = la reazione non avviene, perché possibile base contenente rame - insolubile
2). Interazione con acidi, con conseguente formazione di sale e acqua. (L'ossido di base e gli acidi reagiscono SEMPRE)
K2O + 2HCI = 2KCl + H2O
CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O
3). Interazione con ossidi acidi, con conseguente formazione di sale.
Li2O + CO2 = Li2CO3
3MgO + P2O5 = Mg3 (PO4) 2
4). L'interazione con l'idrogeno produce metallo e acqua.
CuO + H2 = Cu + H2O
Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O
II.Ossidi acidi.
1). Dovrebbe formarsi un'interazione con l'acqua acido.(SoltantoSiO 2 non interagisce con l'acqua)
CO2 + H2O = H2CO3
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4
2). Interazione con basi solubili (alcali). Questo produce sale e acqua.
SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O
N2O5 + 2KOH = 2KNO3 + H2O
3). Interazione con ossidi basici. In questo caso si forma solo sale.
N2O5 + K2O = 2KNO3
Al2O3 + 3SO3 = Al2 (SO4) 3
Esercizi di base.
1). Completa l'equazione della reazione. Determinarne il tipo.
K2O + P2O5 =
Soluzione.
Per scrivere ciò che si forma di conseguenza, è necessario determinare quali sostanze hanno reagito - qui è ossido di potassio (basico) e ossido di fosforo (acido) in base alle proprietà - il risultato dovrebbe essere SALE (vedi proprietà n. 3 ) e il sale è costituito da atomi metallici (nel nostro caso potassio) e da un residuo acido che comprende fosforo (cioè PO 4 -3 - fosfato) Pertanto
3K2O + P2O5 = 2K3RO4
tipo di reazione - composto (poiché due sostanze reagiscono, ma se ne forma una)
2). Effettuare trasformazioni (catena).
Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO
Soluzione
Per completare questo esercizio, devi ricordare che ogni freccia rappresenta un'equazione (una reazione chimica). Numeriamo ogni freccia. Pertanto, è necessario scrivere 4 equazioni. La sostanza scritta a sinistra della freccia (sostanza iniziale) reagisce e la sostanza scritta a destra si forma come risultato della reazione (prodotto di reazione). Decifriamo la prima parte della registrazione:
Ca + …..→ CaO Notiamo che una sostanza semplice reagisce e si forma un ossido. Conoscendo i metodi per produrre ossidi (n. 1), arriviamo alla conclusione che in questa reazione è necessario aggiungere -ossigeno (O 2)
2Ca+O2→2CaO
Passiamo alla trasformazione n. 2
CaO → Ca(OH)2
CaO + ……→ Ca(OH)2
Arriviamo alla conclusione che qui è necessario applicare la proprietà degli ossidi di base - l'interazione con l'acqua, perché solo in questo caso dall'ossido si forma una base.
CaO + H2O → Ca(OH)2
Passiamo alla trasformazione n. 3
Ca(OH)2 → CaCO3
Ca(OH)2 + ….. = CaCO3 + …….
Arriviamo alla conclusione che qui stiamo parlando di anidride carbonica CO 2 perché solo quando interagisce con gli alcali forma un sale (vedi proprietà n. 2 degli ossidi acidi)
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
Passiamo alla trasformazione n. 4
CaCO3 → CaO
CaCO3 = ….. CaO + ……
Arriviamo alla conclusione che qui si forma più CO 2, perché CaCO 3 è un sale insolubile ed è durante la decomposizione di tali sostanze che si formano gli ossidi.
CaCO3 = CaO + CO2
3). Con quale delle seguenti sostanze interagisce la CO2? Scrivi le equazioni di reazione.
UN). Acido cloridrico B). Idrossido di sodio B). Ossido di potassio d). Acqua
D). Idrogeno E). Ossido di zolfo (IV).
Determiniamo che la CO 2 è un ossido acido. E gli ossidi acidi reagiscono con acqua, alcali e ossidi basici... Pertanto, dall'elenco fornito, selezioniamo le risposte B, C, D, ed è con loro che scriviamo le equazioni di reazione:
1). CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O
2). CO2 + K2O = K2CO3
Prima di iniziare a parlare delle proprietà chimiche degli ossidi, dobbiamo ricordare che tutti gli ossidi sono divisi in 4 tipi: basici, acidi, anfoteri e non salini. Per determinare la tipologia di un qualsiasi ossido, prima di tutto bisogna capire se si tratta di un ossido metallico o non metallico, e poi utilizzare l'algoritmo (devi impararlo!) presentato nella tabella seguente :
| Ossido non metallico | Ossido di metallo |
| 1) Stato di ossidazione del non metallo +1 o +2 Conclusione: ossido che non forma sale Eccezione: Cl 2 O non è un ossido che non forma sale |
1) Stato di ossidazione del metallo +1 o +2 Conclusione: l'ossido di metallo è basilare Eccezione: BeO, ZnO e PbO non sono ossidi basici |
| 2) Lo stato di ossidazione è maggiore o uguale a +3 Conclusione: ossido acido Eccezione: Cl 2 O è un ossido acido, nonostante lo stato di ossidazione del cloro +1 |
2) Stato di ossidazione del metallo +3 o +4 Conclusione: ossido anfotero Eccezione: BeO, ZnO e PbO sono anfoteri, nonostante lo stato di ossidazione +2 dei metalli 3) Stato di ossidazione del metallo +5, +6, +7 Conclusione: ossido acido |
Oltre ai tipi di ossidi sopra indicati, introdurremo anche altri due sottotipi di ossidi basici, in base alla loro attività chimica, vale a dire ossidi basici attivi E ossidi basici poco attivi.
- A ossidi basici attivi Includiamo gli ossidi dei metalli alcalini e alcalino terrosi (tutti gli elementi dei gruppi IA e IIA, eccetto l'idrogeno H, il berillio Be e il magnesio Mg). Ad esempio, Na 2 O, CaO, Rb 2 O, SrO, ecc.
- A ossidi basici poco attivi includeremo tutti i principali ossidi non presenti nell'elenco ossidi basici attivi. Ad esempio FeO, CuO, CrO, ecc.
È logico supporre che gli ossidi basici attivi spesso entrino in reazioni che quelli poco attivi non fanno.
Va notato che nonostante il fatto che l'acqua sia in realtà un ossido di un non metallo (H 2 O), le sue proprietà sono solitamente considerate separatamente dalle proprietà di altri ossidi. Ciò è dovuto alla sua distribuzione particolarmente ampia nel mondo che ci circonda, e quindi nella maggior parte dei casi l'acqua non è un reagente, ma un mezzo in cui possono avvenire innumerevoli reazioni chimiche. Tuttavia, spesso prende parte direttamente a varie trasformazioni, in particolare con esso reagiscono alcuni gruppi di ossidi.
Quali ossidi reagiscono con l'acqua?
Di tutti gli ossidi con acqua reagire
soltanto:
1) tutti gli ossidi basici attivi (ossidi di metalli alcalini e metalli alcalini);
2) tutti gli ossidi acidi, eccetto il biossido di silicio (SiO 2);
quelli. Da quanto sopra ne consegue esattamente con l'acqua non reagire:
1) tutti gli ossidi basici a bassa attività;
2) tutti gli ossidi anfoteri;
3) ossidi non salini (NO, N 2 O, CO, SiO).
La capacità di determinare quali ossidi possono reagire con l'acqua anche senza la capacità di scrivere le corrispondenti equazioni di reazione consente già di ottenere punti per alcune domande nella parte di prova dell'Esame di Stato Unificato.
Ora scopriamo come reagiscono alcuni ossidi con l'acqua, ad es. Impariamo a scrivere le equazioni di reazione corrispondenti.
Ossidi basici attivi, reagendo con l'acqua, formano i corrispondenti idrossidi. Ricordiamo che il corrispondente ossido metallico è un idrossido che contiene il metallo nello stesso stato di ossidazione dell'ossido. Quindi, ad esempio, quando gli ossidi basici attivi K +1 2 O e Ba +2 O reagiscono con l'acqua, si formano i loro corrispondenti idrossidi K +1 OH e Ba +2 (OH) 2:
K2O + H2O = 2KOH- idrossido di potassio
BaO + H2O = Ba(OH)2– idrossido di bario
Tutti gli idrossidi corrispondenti agli ossidi basici attivi (ossidi di metalli alcalini e metalli alcalini) appartengono agli alcali. Gli alcali sono tutti gli idrossidi metallici altamente solubili in acqua, così come l'idrossido di calcio Ca(OH) 2 scarsamente solubile (come eccezione).
L'interazione degli ossidi acidi con l'acqua, nonché la reazione degli ossidi basici attivi con l'acqua, porta alla formazione dei corrispondenti idrossidi. Solo nel caso degli ossidi acidi essi corrispondono non a quelli basici, ma a idrossidi acidi, più spesso chiamati acidi contenenti ossigeno. Ricordiamo che il corrispondente ossido acido è un acido contenente ossigeno che contiene un elemento acidogeno nello stesso stato di ossidazione dell'ossido.
Quindi, se, ad esempio, vogliamo scrivere l'equazione per l'interazione dell'ossido acido SO 3 con l'acqua, dobbiamo prima ricordare i principali acidi contenenti zolfo studiati nel curriculum scolastico. Questi sono idrogeno solforato H 2 S, acidi solforosi H 2 SO 3 e acidi solforici H 2 SO 4. L'acido idrogeno solforato H 2 S, come è facile vedere, non contiene ossigeno, quindi la sua formazione durante l'interazione di SO 3 con acqua può essere immediatamente esclusa. Degli acidi H 2 SO 3 e H 2 SO 4, solo l'acido solforico H 2 SO 4 contiene zolfo nello stato di ossidazione +6, come nell'ossido SO 3. Pertanto, è proprio questo che si formerà nella reazione di SO 3 con acqua:
H2O + SO3 = H2SO4
Allo stesso modo, l'ossido N 2 O 5, contenente azoto nello stato di ossidazione +5, reagendo con l'acqua, forma acido nitrico HNO 3, ma in nessun caso nitroso HNO 2, poiché nell'acido nitrico lo stato di ossidazione dell'azoto è lo stesso dell'azoto N 2 O 5 , è uguale a +5 e in azoto - +3:
N+52O5 + H2O = 2HN+5O3
Interazione degli ossidi tra loro
Prima di tutto, è necessario comprendere chiaramente il fatto che tra gli ossidi salini (acidi, basici, anfoteri), le reazioni non si verificano quasi mai tra ossidi della stessa classe, ad es. Nella stragrande maggioranza dei casi l’interazione è impossibile:
1) ossido basico + ossido basico ≠
2) ossido acido + ossido acido ≠
3) ossido anfotero + ossido anfotero ≠
Mentre l'interazione è quasi sempre possibile tra ossidi appartenenti a tipologie diverse, cioè quasi sempre stanno perdendo reazioni tra:
1) ossido basico e ossido acido;
2) ossido anfotero e ossido acido;
3) ossido anfotero e ossido basico.
Come risultato di tutte queste interazioni, il prodotto è sempre un sale medio (normale).
Consideriamo più in dettaglio tutte queste coppie di interazioni.
Come risultato dell'interazione:
Me x O y + ossido acido, dove Me x O y – ossido metallico (basico o anfotero)
si forma un sale costituito dal catione metallico Me (dall'iniziale Me x O y) e dal residuo acido dell'acido corrispondente all'ossido dell'acido.
Ad esempio, proviamo a scrivere le equazioni di interazione per le seguenti coppie di reagenti:
Na2O + P2O5 E Al2O3 + SO3
Nella prima coppia di reagenti vediamo un ossido basico (Na 2 O) e un ossido acido (P 2 O 5). Nel secondo - ossido anfotero (Al 2 O 3) e ossido acido (SO 3).
Come già accennato, a seguito dell'interazione di un ossido basico/anfotero con uno acido, si forma un sale, costituito da un catione metallico (dall'ossido basico/anfotero originario) e da un residuo acido dell'acido corrispondente all'ossido ossido acido originale.
Pertanto, l'interazione di Na 2 O e P 2 O 5 dovrebbe formare un sale costituito da cationi Na + (da Na 2 O) e dal residuo acido PO 4 3-, poiché l'ossido P +5 2 O 5 corrisponde all'acido H 3 P +5 O4. Quelli. Come risultato di questa interazione, si forma il fosfato di sodio:
3Na2O + P2O5 = 2Na3PO4- fosfato di sodio
A sua volta, l'interazione di Al 2 O 3 e SO 3 dovrebbe formare un sale costituito da cationi Al 3+ (da Al 2 O 3) e dal residuo acido SO 4 2-, poiché l'ossido S +6 O 3 corrisponde all'acido H 2 S +6 O4. Pertanto, come risultato di questa reazione, si ottiene il solfato di alluminio:
Al2O3 + 3SO3 = Al2 (SO4) 3- solfato di alluminio
Più specifica è l'interazione tra ossidi anfoteri e basici. Queste reazioni vengono effettuate ad alte temperature e il loro verificarsi è possibile a causa del fatto che l'ossido anfotero assume effettivamente il ruolo di acido. Come risultato di questa interazione, si forma un sale di composizione specifica, costituito da un catione metallico che forma l'ossido basico originale e un “residuo acido”/anione, che comprende il metallo dell'ossido anfotero. La formula generale di tale “residuo acido”/anione può essere scritta come MeO 2 x - , dove Me è un metallo proveniente da un ossido anfotero, e x = 2 nel caso di ossidi anfoteri con formula generale della forma Me + 2 O (ZnO, BeO, PbO) e x = 1 – per ossidi anfoteri con una formula generale della forma Me +3 2 O 3 (ad esempio Al 2 O 3, Cr 2 O 3 e Fe 2 O 3).
Proviamo a scrivere le equazioni di interazione come esempio
ZnO+Na2O E Al2O3 + BaO
Nel primo caso ZnO è un ossido anfotero con formula generale Me +2 O, e Na 2 O è un tipico ossido basico. Secondo quanto sopra, come risultato della loro interazione, si dovrebbe formare un sale, costituito da un catione metallico che forma un ossido basico, cioè nel nostro caso Na + (da Na 2 O) e il “residuo acido”/anione di formula ZnO 2 2-, poiché l'ossido anfotero ha formula generale della forma Me + 2 O. Pertanto, la formula del il sale risultante, soggetto alla condizione di neutralità elettrica di una delle sue unità strutturali (“molecole”), apparirà come Na 2 ZnO 2:
ZnO + Na2O = A=> Na2ZnO2
Nel caso di una coppia interagente di reagenti Al 2 O 3 e BaO, la prima sostanza è un ossido anfotero con la formula generale Me + 3 2 O 3, e la seconda è un tipico ossido basico. In questo caso si forma un sale contenente un catione metallico proveniente dall'ossido principale, cioè Ba 2+ (da BaO) e il “residuo acido”/anione AlO 2 - . Quelli. la formula del sale risultante, soggetto alla condizione di neutralità elettrica di una delle sue unità strutturali (“molecole”), avrà la forma Ba(AlO 2) 2, e l'equazione di interazione stessa sarà scritta come:
Al2O3 + BaO = A=> Ba(AlO2)2
Come abbiamo scritto sopra, la reazione avviene quasi sempre:
Me x O y + ossido acido,
dove Me x O y è un ossido metallico basico o anfotero.
Tuttavia, ci sono due ossidi acidi "schizzinosi" da ricordare: l'anidride carbonica (CO 2) e l'anidride solforosa (SO 2). La loro "pignolo" sta nel fatto che, nonostante le loro evidenti proprietà acide, l'attività di CO 2 e SO 2 non è sufficiente per interagire con gli ossidi basici e anfoteri a bassa attività. Degli ossidi metallici, reagiscono solo con ossidi basici attivi(ossidi di metalli alcalini e metalli alcalini). Ad esempio, Na 2 O e BaO, essendo ossidi basici attivi, possono reagire con essi:
CO2 + Na2O = Na2CO3
SO2 + BaO = BaSO3
Mentre gli ossidi CuO e Al 2 O 3, che non sono legati agli ossidi basici attivi, non reagiscono con CO 2 e SO 2:
CO2 + CuO ≠
CO2 + Al2O3 ≠
SO2 + CuO ≠
SO2 + Al2O3 ≠
Interazione degli ossidi con gli acidi
Gli ossidi basici e anfoteri reagiscono con gli acidi. In questo caso si formano sali e acqua:
FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O
Gli ossidi che non formano sali non reagiscono affatto con gli acidi e nella maggior parte dei casi gli ossidi acidi non reagiscono con gli acidi.
Quando un ossido acido reagisce con un acido?
Quando risolvi la parte a scelta multipla dell'Esame di Stato Unificato, dovresti presupporre condizionatamente che gli ossidi acidi non reagiscono né con gli ossidi acidi né con gli acidi, tranne nei seguenti casi:
1) il biossido di silicio, essendo un ossido acido, reagisce con l'acido fluoridrico, sciogliendosi in esso. In particolare, grazie a questa reazione, il vetro può essere sciolto nell'acido fluoridrico. Nel caso di eccesso di HF, l’equazione di reazione ha la forma:
SiO2 + 6HF = H2 + 2H2O,
e in caso di deficit di HF:
SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O
2) SO 2, essendo un ossido acido, reagisce facilmente con l'acido idrosolfuro simile a H 2 S coproporzionamento:
S +4 O 2 + 2H 2 S -2 = 3S 0 + 2H 2 O
3) L'ossido di fosforo (III) P 2 O 3 può reagire con acidi ossidanti, che includono acido solforico concentrato e acido nitrico di qualsiasi concentrazione. In questo caso lo stato di ossidazione del fosforo aumenta da +3 a +5:
| P2O3 | + | 2H2SO4 | + | H2O | =A=> | 2SO2 | + | 2H3PO4 |
| (concentrato) |
| 3 P2O3 | + | 4HNO3 | + | 7 H2O | =A=> | 4NO | + | 6 H3PO4 |
| (dettagliato) |
| 2HNO3 | + | 3SO2 | + | 2H2O | =A=> | 3H2SO4 | + | 2NO |
| (dettagliato) |
Interazione degli ossidi con idrossidi metallici
Gli ossidi acidi reagiscono con gli idrossidi metallici, sia basici che anfoteri. Questo produce un sale costituito da un catione metallico (dall'idrossido metallico originale) e un residuo acido corrispondente all'ossido acido.
SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O
Gli ossidi acidi, che corrispondono agli acidi polibasici, possono formare sia sali normali che acidi con alcali:
CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O
CO2+NaOH = NaHCO3
P2O5 + 6KOH = 2K3PO4 + 3H2O
P2O5 + 4KOH = 2K2HPO4 + H2O
P2O5 + 2KOH + H2O = 2KH2 PO4
Gli ossidi "schizzinosi" CO 2 e SO 2, la cui attività, come già accennato, non è sufficiente per la loro reazione con ossidi basici e anfoteri a bassa attività, tuttavia reagiscono con la maggior parte dei corrispondenti idrossidi metallici. Più precisamente l'anidride carbonica e l'anidride solforosa reagiscono con gli idrossidi insolubili sotto forma di loro sospensione in acqua. In questo caso, solo quello di base O sali naturali chiamati idrossicarbonati e idrossisolfiti e la formazione di sali intermedi (normali) è impossibile:
2Zn(OH)2 + CO2 = (ZnOH)2CO3 + H2O(in soluzione)
2Cu(OH)2 + CO2 = (CuOH)2CO3 + H2O(in soluzione)
Tuttavia, l'anidride carbonica e l'anidride solforosa non reagiscono affatto con gli idrossidi metallici nello stato di ossidazione +3, ad esempio come Al(OH) 3, Cr(OH) 3, ecc.
Va inoltre notato che il biossido di silicio (SiO 2) è particolarmente inerte, molto spesso presente in natura sotto forma di sabbia ordinaria. Questo ossido è acido, ma tra gli idrossidi metallici è in grado di reagire solo con soluzioni concentrate (50-60%) di alcali, nonché con alcali puri (solidi) durante la fusione. In questo caso si formano silicati:
2NaOH + SiO2 = A=> Na2SiO3 + H2O
Gli ossidi anfoteri degli idrossidi metallici reagiscono solo con gli alcali (idrossidi di metalli alcalini e alcalino terrosi). In questo caso, quando la reazione viene condotta in soluzioni acquose, si formano sali complessi solubili:
ZnO + 2NaOH + H2O = Na2- tetraidrossizincato di sodio
BeO + 2NaOH + H2O = Na2- tetraidrossiberillato di sodio
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na- tetraidrossialluminato di sodio
Cr2O3 + 6NaOH + 3H2O = 2Na3- esaidrossicromato di sodio (III)
E quando questi stessi ossidi anfoteri vengono fusi con alcali, si ottengono sali costituiti da un catione di metallo alcalino o alcalino terroso e da un anione del tipo MeO 2 x -, dove X= 2 nel caso dell'ossido anfotero di tipo Me+2O e X= 1 per un ossido anfotero della forma Me 2 +2 O 3:
ZnO + 2NaOH = A=> Na2ZnO2 + H2O
BeO + 2NaOH = A=> Na2BeO2 + H2O
Al2O3 + 2NaOH = A=> 2NaAlO2 + H2O
Cr2O3 + 2NaOH = A=> 2NaCrO2 + H2O
Fe2O3 + 2NaOH = A=> 2NaFeO2 + H2O
È da notare che i sali ottenuti dalla fusione di ossidi anfoteri con alcali solidi possono essere facilmente ottenuti da soluzioni dei corrispondenti sali complessi mediante evaporazione e successiva calcinazione:
Na2= A=> Na2ZnO2 + 2H2O
Na = A=> NaAlO2 + 2H2O
Interazione degli ossidi con sali medi
Molto spesso, i sali medi non reagiscono con gli ossidi.
Tuttavia, dovresti conoscere le seguenti eccezioni a questa regola, che si incontrano spesso durante l'esame.
Una di queste eccezioni è che gli ossidi anfoteri, così come il biossido di silicio (SiO 2), quando fusi con solfiti e carbonati, spostano rispettivamente il biossido di zolfo (SO 2) e il biossido di carbonio (CO 2) da questi ultimi. Per esempio:
Al2O3 + Na2CO3 = A=> 2NaAlO2 + CO2
SiO2 + K2SO3 = A=> K2SiO3 + SO2
Inoltre, le reazioni degli ossidi con i sali possono includere condizionatamente l'interazione dell'anidride solforosa e dell'anidride carbonica con soluzioni acquose o sospensioni dei sali corrispondenti - solfiti e carbonati, che portano alla formazione di sali acidi:
Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
Inoltre, l'anidride solforosa, quando passa attraverso soluzioni acquose o sospensioni di carbonati, sposta l'anidride carbonica da esse a causa del fatto che l'acido solforoso è un acido più forte e più stabile dell'acido carbonico:
K2CO3 + SO2 = K2SO3 + CO2
ORR che coinvolge gli ossidi
Riduzione degli ossidi metallici e non metallici
Proprio come i metalli possono reagire con soluzioni di sali di metalli meno attivi, sostituendo questi ultimi in forma libera, anche gli ossidi metallici quando riscaldati sono in grado di reagire con metalli più attivi.
Ricordiamo che l'attività dei metalli può essere confrontata utilizzando la serie di attività dei metalli o, se uno o due metalli non sono nella serie di attività, in base alla loro posizione relativa l'uno rispetto all'altro nella tavola periodica: quello inferiore e quello inferiore lasciato il metallo, più è attivo. È anche utile ricordare che qualsiasi metallo della famiglia AHM e ALP sarà sempre più attivo di un metallo che non sia rappresentativo di ALM o ALP.
In particolare, il metodo dell'alluminotermia, utilizzato nell'industria per ottenere metalli difficili da ridurre come cromo e vanadio, si basa sull'interazione di un metallo con l'ossido di un metallo meno attivo:
Cr2O3 + 2Al = A=> Al2O3+2Cr
Durante il processo di alluminotermia viene generata un'enorme quantità di calore e la temperatura della miscela di reazione può raggiungere più di 2000°C.
Inoltre, gli ossidi di quasi tutti i metalli situati nella serie di attività a destra dell'alluminio possono essere ridotti a metalli liberi dall'idrogeno (H 2), dal carbonio (C) e dal monossido di carbonio (CO) quando riscaldati. Per esempio:
Fe2O3 + 3CO = A=> 2Fe+3CO2
CuO+C= A=>Cu+CO
FeO + H2 = A=> Fe+H2O
È da notare che se il metallo può avere più stati di ossidazione, se manca l'agente riducente utilizzato è possibile anche una riduzione incompleta degli ossidi. Per esempio:
Fe2O3 + CO =t o=> 2FeO + CO2
4CuO + C = A=> 2Cu2O + CO2
Ossidi di metalli attivi (alcalini, alcalino terrosi, magnesio e alluminio) con idrogeno e monossido di carbonio non reagire.
Tuttavia, gli ossidi di metalli attivi reagiscono con il carbonio, ma in modo diverso rispetto agli ossidi di metalli meno attivi.
Nell'ambito del programma di esame di stato unificato, per non essere confuso, si dovrebbe presumere che come risultato della reazione degli ossidi di metalli attivi (fino ad Al compreso) con il carbonio, la formazione di metalli alcalini liberi, metalli alcalini metallo, Mg e Al è impossibile. In questi casi si formano carburo metallico e monossido di carbonio. Per esempio:
2Al2O3+9C= A=> Al4C3+6CO
CaO + 3C = A=> CaC2+CO
Gli ossidi dei non metalli possono spesso essere ridotti dai metalli in non metalli liberi. Ad esempio, quando riscaldati, gli ossidi di carbonio e silicio reagiscono con i metalli alcalini, alcalino terrosi e il magnesio:
CO2 + 2Mg = A=> 2MgO+C
SiO2 + 2Mg = A=>Si+2MgO
Con un eccesso di magnesio anche quest'ultima interazione può portare alla formazione siliciuro di magnesio Mg2Si:
SiO2 + 4Mg = A=> Mg2Si + 2 MgO
Gli ossidi di azoto possono essere ridotti con relativa facilità anche con metalli meno attivi, come zinco o rame:
Zn + 2NO = A=> ZnO+N2
NO2 + 2Cu = A=> 2CuO+N2
Interazione degli ossidi con l'ossigeno
Per poter rispondere alla domanda se qualche ossido reagisce con l'ossigeno (O 2) nei compiti del vero Esame di Stato Unificato, è necessario prima ricordare che gli ossidi che possono reagire con l'ossigeno (tra quelli che potresti incontrare nell'esame stesso) possono formare solo elementi chimici dall'elenco:
Gli ossidi di qualsiasi altro elemento chimico presente nel vero Esame di Stato Unificato reagiscono con l'ossigeno non lo farà (!).
Per una memorizzazione più visiva e comoda dell'elenco degli elementi sopra elencati, a mio avviso, è conveniente la seguente illustrazione:
Tutti gli elementi chimici in grado di formare ossidi che reagiscono con l'ossigeno (tra quelli riscontrati durante l'esame)
Innanzitutto tra gli elementi elencati va considerato l'azoto N, perché il rapporto tra i suoi ossidi e l'ossigeno differisce notevolmente dagli ossidi di altri elementi nell'elenco sopra.
Va ricordato chiaramente che l'azoto può formare complessivamente cinque ossidi e precisamente:
Di tutti gli ossidi di azoto che possono reagire con l'ossigeno soltanto NO. Questa reazione avviene molto facilmente quando l'NO viene miscelato sia con ossigeno puro che con aria. In questo caso si osserva un rapido cambiamento nel colore del gas da incolore (NO) a marrone (NO 2):
| 2NO | + | O2 | = | 2NO2 |
| incolore | marrone |
Per rispondere alla domanda: qualsiasi ossido di qualsiasi altro degli elementi chimici sopra elencati reagisce con l'ossigeno (cioè CON,Sì, P, S, Cu, Mn, Fe, Cr) — Prima di tutto, devi ricordarli di base stato di ossidazione (CO). Eccoli :
Occorre poi ricordare che tra gli eventuali ossidi dei suddetti elementi chimici, solo quelli che contengono l'elemento nello stato di ossidazione minimo tra quelli sopra indicati reagiranno con l'ossigeno. In questo caso, lo stato di ossidazione dell'elemento aumenta fino al valore positivo più vicino possibile:
| elemento |
Il rapporto dei suoi ossidiall'ossigeno |
| CON | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positiva del carbonio è pari a +2
, e quello positivo più vicino è +4
. Pertanto, solo la CO reagisce con l'ossigeno degli ossidi C +2 O e C +4 O 2. In questo caso avviene la reazione: 2C+2O+O2= A=> 2C+4O2 CO2+O2≠- la reazione è impossibile in linea di principio, perché +4 – il più alto grado di ossidazione del carbonio. |
| Sì | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positivi del silicio è +2, e quello positivo più vicino ad esso è +4. Pertanto, solo SiO reagisce con l'ossigeno degli ossidi Si +2 O e Si +4 O 2. A causa di alcune caratteristiche degli ossidi SiO e SiO 2 è possibile l'ossidazione solo di una parte degli atomi di silicio nell'ossido Si + 2 O. per effetto della sua interazione con l'ossigeno si forma un ossido misto contenente sia silicio nello stato di ossidazione +2 che silicio nello stato di ossidazione +4, precisamente Si 2 O 3 (Si +2 O·Si +4 O 2): 4Si+2O+O2= A=> 2Si +2 ,+4 2 O 3 (Si +2 O·Si +4 O 2) SiO2 + O2 ≠- la reazione è impossibile in linea di principio, perché +4 – il più alto stato di ossidazione del silicio. |
| P | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positivi del fosforo è +3, e quello positivo più vicino ad esso è +5. Pertanto, solo P 2 O 3 reagisce con l'ossigeno degli ossidi P +3 2 O 3 e P +5 2 O 5. In questo caso, la reazione di ulteriore ossidazione del fosforo con l'ossigeno avviene dallo stato di ossidazione +3 allo stato di ossidazione +5: P+32O3+O2= A=>P+52O5 P +5 2 O 5 + O 2 ≠- la reazione è impossibile in linea di principio, perché +5 – il più alto stato di ossidazione del fosforo. |
| S | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positiva dello zolfo è +4 e lo stato di ossidazione positiva più vicino ad esso è +6. Pertanto solo la SO 2 reagisce con l'ossigeno degli ossidi S +4 O 2 e S +6 O 3 . In questo caso avviene la reazione: 2S +4 O2 + O2 = A=> 2S+6O3 2S +6 O3 + O2 ≠- la reazione è impossibile in linea di principio, perché +6 – il più alto grado di ossidazione dello zolfo. |
| Cu | Il minimo tra gli stati di ossidazione positivi del rame è +1 e il valore più vicino ad esso è positivo (e l'unico) +2. Pertanto, solo Cu 2 O reagisce con l'ossigeno degli ossidi Cu +1 2 O, Cu +2 O. In questo caso, avviene la reazione: 2Cu+12O+O2= A=> 4Cu +2O CuO+O2≠- la reazione è impossibile in linea di principio, perché +2 – il più alto stato di ossidazione del rame. |
| Cr | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positivi del cromo è +2, e quello positivo più vicino ad esso è +3. Pertanto, solo CrO reagisce con l'ossigeno degli ossidi Cr +2 O, Cr +3 2 O 3 e Cr +6 O 3, mentre viene ossidato dall'ossigeno al successivo (possibile) stato di ossidazione positivo, cioè +3: 4Cr+2O+O2= A=> 2Cr +3 2 O 3 Cr +3 2 O 3 + O 2 ≠- la reazione non procede, nonostante esista ossido di cromo e in uno stato di ossidazione superiore a +3 (Cr +6 O 3). L'impossibilità che questa reazione avvenga è dovuta al fatto che il riscaldamento necessario per la sua ipotetica realizzazione supera ampiamente la temperatura di decomposizione dell'ossido di CrO 3 . Cr +6 O 3 + O 2 ≠ — questa reazione non può procedere in linea di principio, perché +6 è il più alto stato di ossidazione del cromo. |
| Mn | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positivi del manganese è +2, e quello positivo più vicino è +4. Pertanto, dei possibili ossidi Mn +2 O, Mn +4 O 2, Mn +6 O 3 e Mn +7 2 O 7, solo MnO reagisce con l'ossigeno, mentre viene ossidato dall'ossigeno al successivo (possibile) stato di ossidazione positivo , t.e. +4: 2Mn+2O+O2= A=> 2Mn+4O2 Mentre: Mn +4 O 2 + O 2 ≠ E Mn +6 O 3 + O 2 ≠- le reazioni non si verificano, nonostante sia presente ossido di manganese Mn 2 O 7 contenente Mn in uno stato di ossidazione maggiore di +4 e +6. Ciò è dovuto al fatto che è necessaria un'ulteriore ipotetica ossidazione degli ossidi di Mn +4 O2 e Mn +6 Il riscaldamento di O 3 supera significativamente la temperatura di decomposizione degli ossidi risultanti MnO 3 e Mn 2 O 7. Mn +7 2 O 7 + O 2 ≠- questa reazione è impossibile in linea di principio, perché +7 – il più alto stato di ossidazione del manganese. |
| Fe | Il minimo tra i principali stati di ossidazione positivi del ferro è pari a +2
, e quello più vicino tra quelli possibili è +3
. Nonostante il ferro esista uno stato di ossidazione +6, l'ossido acido FeO 3, così come il corrispondente acido "ferro", non esiste. Pertanto, tra gli ossidi di ferro, solo quegli ossidi che contengono Fe nello stato di ossidazione +2 possono reagire con l'ossigeno. O è ossido di Fe +2 O, o ossido di ferro misto Fe +2 ,+3 3 O 4 (scaglia di ferro):
ossido misto Fe +2,+3 3 O 4 può essere ossidato a Fe +3 2O3:
Fe +3 2 O 3 + O 2 ≠ - questa reazione è impossibile in linea di principio, perché Non esistono ossidi contenenti ferro in uno stato di ossidazione superiore a +3. |