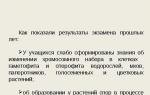Emergenze causate da malattie infettive degli animali da reddito e selvatici
Malattie infettive degli animali– un gruppo di malattie che hanno caratteristiche comuni come la presenza di un agente patogeno specifico, lo sviluppo ciclico, la capacità di trasmettersi da un animale infetto a uno sano e diventare epizootica. Causato da batteri patogeni, funghi, virus, rickettsia.
Malattia infettiva– una forma di espressione del complesso di reazioni protettive e adattative dell’organismo alle infezioni. Molte malattie infettive degli animali, come la brucellosi, l'antrace, la rabbia, ecc., vengono trasmesse all'uomo.
Tutte le malattie infettive degli animali sono divise in cinque gruppi:
Infezioni nutrizionali che colpiscono gli organi dell'apparato digerente. Trasmesso attraverso il suolo, il cibo, l'acqua. Questi includono l'antrace, l'afta epizootica, la morva, ecc.;
Infezioni respiratorie che portano a danni alle mucose delle vie respiratorie e dei polmoni. La principale via di trasmissione sono le goccioline trasportate dall'aria. Questi includono: parainfluenza, polmonite enzootica, vaiolo ovino e caprino, peste canina;
Infezioni trasmesse da vettori trasmesse da artropodi succhiatori di sangue. Questi includono: encefalomielite, tularemia, anemia infettiva dei cavalli;
Infezioni i cui agenti patogeni vengono trasmessi attraverso la pelle esterna senza la partecipazione di vettori. Questi includono il tetano, la rabbia, il vaiolo bovino;
Infezioni con vie di infezione sconosciute.
La diffusione delle malattie animali infettive avviene sotto forma di enzootica, epizootica e panzootica.
Enzootico– la diffusione simultanea di una malattia infettiva tra gli animali da allevamento in una determinata area, azienda agricola o punto le cui condizioni naturali ed economiche escludono la diffusione su vasta scala di tale malattia.
Epizootico- diffusione simultanea di una malattia infettiva che progredisce nel tempo e nello spazio all'interno di una determinata regione tra un gran numero di una o più specie di animali da allevamento, superando significativamente il tasso di incidenza normalmente registrato in un dato territorio.
Panzoozia– diffusione massiccia e simultanea di una malattia infettiva degli animali da allevamento con un alto tasso di incidenza su un vasto territorio, che copre intere regioni, diversi paesi e continenti.
Le principali malattie infettive più pericolose degli animali
Rabbia– una malattia infettiva acuta che è causata da un virus che penetra nella ferita e raggiunge il sistema nervoso centrale. Cani, cavalli e bovini hanno una maggiore suscettibilità alla rabbia.
Sintomi della malattia: nei bovini, la rabbia si manifesta in forma tranquilla: non c'è aggressività, si sviluppano rapidamente sbavature, muggiti rauchi, paralisi della faringe, della mascella inferiore, degli arti posteriori, mancanza di appetito, movimenti forzati e andatura instabile. L'animale muore in stato comatoso.
Misure di prevenzione: gli animali malati non vengono curati, ma isolati e uccisi una volta confermata la diagnosi. I cani sono spesso vaccinati. Gli animali che hanno morso persone o altri animali vengono osservati per 10 giorni. Le persone che sono state morse vengono vaccinate e ricevono una serie di trattamenti.
Peste bovina- una pericolosa malattia infettiva. I sintomi della malattia e le misure preventive sono simili a quelli dell’uomo.
Vaiolo- malattia infettiva acuta. La malattia colpisce l’uomo e tutti i tipi di animali.
Sintomi: si verificano in una delle forme: vaiolo o difterite. Macchie giallo pallido sotto forma di tubercoli compaiono su varie parti del corpo degli uccelli, soprattutto nella zona della cresta e del mento, sulla pelle delle palpebre e degli arti; si seccano e cadono. Se non ci sono complicazioni, gli animali guariscono.
Misure di prevenzione: gli animali vengono tenuti in quarantena e vaccinati. Gli animali morti vengono bruciati.
Leucosi bovina– malattia infettiva cronica. È causata da un virus e colpisce animali con deficit immunologico. Caratterizzato da cambiamenti nella composizione del sangue.
Sintomi: si manifesta sotto forma di linfocitosi e formazioni maligne in organi e tessuti. Si osserva nei linfonodi ingrossati senza reazione termica, anemia, attività cardiaca indebolita e indigestione.
Misure di prevenzione: esame regolare del bestiame utilizzando metodi clinici e di altro tipo. Distruzione di animali malati.
afta epizootica– una malattia virale degli animali artiodattili. La malattia del pollame si diffonde. È caratterizzata da febbre e lesioni autozoe della mucosa del cavo orale, della pelle, della mammella e degli arti. Le fonti dell'afta epizootica sono animali malati. Il virus si trasmette attraverso il latte, l'urina e le feci. Si trasmette all'uomo attraverso il contatto con un animale malato e i suoi prodotti. Quando il latte viene pastorizzato, il virus muore dopo 30 minuti; quando il latte viene bollito, dopo 5 minuti.
Sintomi: la temperatura sale a 41 C, aumenta la salivazione dalla bocca, compaiono bolle piene di liquido sulla lingua, sulle labbra, sulle ali del naso e vicino agli zoccoli.
Misure di prevenzione: vaccinazione di massa di bovini, caprini, pecore, suini.
La malattia di Teschen- malattie infettive dei suini. La malattia si manifesta più spesso in primavera e in autunno con lo sviluppo di encefalite o encefalomielite. È caratterizzato da un aumento della temperatura fino a 41°C, che provoca convulsioni e paralisi degli arti.
Pseudopeste degli uccelli- una malattia virale degli uccelli dell'ordine Gallini. Caratterizzato da danni al sistema respiratorio, digestivo e nervoso centrale. Le fonti della malattia sono gli uccelli malati e guariti che rilasciano virus attraverso tutte le secrezioni, con le uova e l'aria espirata. Il periodo di incubazione è di 24 ore. L'infezione avviene più spesso attraverso il cibo, l'acqua e l'aria, solitamente nel periodo autunno-estivo. La mortalità è del 60-90%.
Psittacosi– una malattia focale naturale infettiva di molti uccelli, compresi quelli indoor, nonché di mammiferi e esseri umani. Caratterizzato da polmonite atipica, peritonite fibrosa, encefalite.
Sintomi: naso che cola, gli uccelli starnutiscono e sfregano le ali contro la superficie degli oggetti, paralisi degli arti alari.
Misure preventive: gli uccelli malati vengono distrutti.
Malattia di Newcastle degli uccelli più comune tra i rappresentanti dell'ordine Gallini. Una persona può essere un portatore passivo.
Sintomi: letargia, disordine, bassa schiudibilità dei polli, respiro sibilante, cessazione della deposizione delle uova, cianosi della cresta e degli orecchini, difficoltà di respirazione, ali cadenti.
Misure di prevenzione: gli uccelli vengono vaccinati. Quando viene rilevata una malattia, vengono tipizzati i virus.
Epatite infettiva– una malattia virale dei cani e di altri carnivori (volpi artiche, volpi, lupi). Caratterizzato da febbre, infiammazione delle mucose e danni al fegato.
Sintomi: sistema immunitario indebolito, stato depresso, ipertermia fino a 40-41 ° C, manifestazioni di gastroenterite acuta, diarrea, manifestazioni di disturbi del sistema cardiovascolare e respiratorio.
Misure di prevenzione: uso di sieri associati (polivalenti) di produzione straniera e nazionale
Encefalite trasmessa da zecche– un’infezione virale naturalmente focale trasmissibile (trasmessa dalle zecche), caratterizzata da un danno predominante al sistema nervoso centrale.
Sintomi: indipendentemente dalla forma clinica, i pazienti manifestano manifestazioni infettive generali di malattie, caratterizzate da febbre e altri segni della sindrome di intossicazione infettiva generale. Il periodo di incubazione dell'encefalite da zecche dura in media 7-14 giorni con fluttuazioni da un giorno a 30 giorni. Appaiono debolezza, malessere, debolezza; Si avvertono lievi dolori ai muscoli del collo e del cingolo scapolare, dolori nella regione lombare e sensazione di intorpidimento, mal di testa.
Misure preventive: quando si visitano le foreste, indossare indumenti adeguatamente selezionati. In caso di zecca succhiata, afferrarla con una pinzetta o con le dita avvolte in una garza e rimuoverla dalla pelle con movimenti lenti e fluidi in modo che la proboscide non si rompa.
Aggiornato il 21/11/2013 12:43 21.11.2013 12:34
Le malattie virali sono molto diffuse in natura: malattie di animali, uccelli, pesci, insetti e persino batteri che causano malattie gravi. Le particelle virali entrano nel corpo dell'animale in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, attraverso il cibo e il mangime, e il virus può anche entrare attraverso gli organi respiratori. Se le malattie virali vengono trattate prematuramente e in modo inadeguato, il risultato sarà fatale.
Elenco delle malattie virali più comuni.
Adenovirus canino;
Rabbia;
Epatite virale;
Peritonite virale felina;
Enterite da parvovirus;
Rinotracheite felina;
Sintomi di malattie virali:
Sintomi dell'adenovirus nei cani:
L’adenovirus è una malattia respiratoria contagiosa. La fonte diretta dell’infezione sono i cani che hanno già questa malattia. Un cane sano può facilmente essere infettato da un cane malato diffondendo il virus nelle urine, nelle feci, attraverso le mucose della cavità nasale o orale e attraverso i rapporti sessuali. Segni di adenovirus nei cani: il cane diventa depresso, arrossamento della mucosa faringea. I cani sperimentano anche respiro sibilante nei polmoni, tosse secca e umida e, in rari casi, il cane può manifestare diarrea e vomito. L'animale sembra letargico e c'è anche una diminuzione dell'appetito. Qualsiasi cane di qualsiasi età può essere infettato dall'adenovirus.
Sintomi della rabbia negli animali domestici:
Le malattie della rabbia compaiono più spesso dopo un mese e mezzo o due mesi, ma i segni della rabbia stessa compaiono 16-26 giorni dopo l'infezione. L'encefalite determina tutti i segni e i sintomi della rabbia. Gli animali domestici affettuosi e docili possono diventare aggressivi e irritabili nel tempo.
Esistono due forme di encefalite: aggressiva e paralitica.
Nella forma aggressiva l'animale diventa aggressivo, feroce e attacca il proprietario. Compaiono convulsioni, contrazioni muscolari convulsive e tremori.
Forma paralitica: l'animale non mangia né beve, la causa è la paralisi progressiva, che priva completamente la capacità di compiere movimenti di deglutizione.
Sintomi dell'epatite virale.
L’epatite virale può manifestarsi in 4 forme:
Super acuto;
subacuto;
Cronico.
Nella forma acuta dell'epatite virale, si osserva uno stato depressivo negli animali, rifiuto di mangiare, accumulo di calore in eccesso nel corpo dell'animale fino a 40-41 ◦ C, vomito frequente misto a bile, diarrea e altri sintomi. Oltre a questi sintomi, gli animali possono anche manifestare disturbi del sistema cardiovascolare e respiratorio e sviluppare rinite. Nella forma iperacuta della malattia la morte dell'animale avviene all'improvviso; quando si verificano le convulsioni avviene entro un giorno.
Forme subacute e croniche di epatite virale.
Negli animali si osservano disturbi d'organo aspecifici. Potresti anche notare un aumento della temperatura, che ritorna normale nel tempo, una diminuzione dell'appetito, un rapido affaticamento e spesso diarrea o stitichezza. Se una femmina è incinta e soffre di epatite virale cronica, potrebbe avere un aborto spontaneo o un feto morto.
Se noti anche un solo sintomo nel tuo animale domestico, contatta immediatamente il veterinario. Il medico determinerà il grado di sviluppo della malattia e prescriverà un trattamento.
Sintomi peritonite virale nei gatti
 Sintomi primari della peritonite felina: perdita di appetito, perdita di peso, il gatto diventa meno attivo e la temperatura aumenta. Il volume addominale del gatto aumenta in modo significativo a causa dello sviluppo dell'ascite. Quando si manifesta clinicamente, il gatto perde peso corporeo, si verifica la depressione e compaiono segni di danno agli organi. Durante il decorso umido della malattia nei gatti, un liquido viscoso trasparente si accumula nel torace e nella cavità addominale. Con la peritonite secca nei gatti, sono comuni danni al sistema nervoso e agli occhi.
Sintomi primari della peritonite felina: perdita di appetito, perdita di peso, il gatto diventa meno attivo e la temperatura aumenta. Il volume addominale del gatto aumenta in modo significativo a causa dello sviluppo dell'ascite. Quando si manifesta clinicamente, il gatto perde peso corporeo, si verifica la depressione e compaiono segni di danno agli organi. Durante il decorso umido della malattia nei gatti, un liquido viscoso trasparente si accumula nel torace e nella cavità addominale. Con la peritonite secca nei gatti, sono comuni danni al sistema nervoso e agli occhi.
Sintomi di enterite da parvovirus
I segni clinici dell'enterite da parvovirus possono manifestarsi in vari gradi. Il grado di sviluppo di questa malattia è solitamente suddiviso in misto, forma intestinale, cardiaca, a seconda dei sintomi prevalenti.
A forma mista sono colpiti principalmente i sistemi cardiaco, respiratorio e digestivo. Spesso la forma mista appare in quegli animali che hanno un'immunità molto debole, cioè negli animali giovani.
La forma intestinale è caratterizzata dal decorso acuto e subacuto della malattia. L'animale rifiuta cibo e acqua, il motivo del rifiuto è una lesione emorragica nell'intestino crasso e tenue. Uno dei principali sintomi della forma intestinale è il vomito incontrollabile per diversi giorni. Dopo due o tre giorni, l'animale inizia ad avere una grave diarrea, che dura per 10 giorni.
La forma cardiaca della malattia colpisce più spesso cuccioli e gattini di 1-3 mesi. Questa forma è caratterizzata da un danno acuto al miocardio (muscoli cardiaci). Gattini e cuccioli rifiutano cibo, acqua e persino il latte materno. Dopo di che gli animali giovani sperimentano grave debolezza, polso irregolare e insufficienza cardiaca. La morte dell'animale può avvenire entro 2-3 giorni.
Sintomi della rinotracheite nei gatti
Nei gatti adulti con un sistema immunitario forte, la rinotracheite si presenta spesso in forma latente, come una rinite lieve. Dopo una settimana la malattia diventa cronica. Quando un'enorme quantità di virus entra nel corpo, nei gattini con un sistema immunitario debole, la malattia può manifestarsi in forme acute e subacute.
Il decorso acuto della rinotracheite nei gatti è caratterizzato da secrezione nasale chiara e starnuti. Per 2-3 giorni il gatto si sdraia costantemente e non risponde alla voce del proprietario. Quindi i bronchi del gatto si infiammano, si verifica tosse con espettorato e la temperatura sale a 41 ◦ C. Il naso del gatto è intasato, il che impedisce la normale respirazione e il gatto inizia a respirare attraverso la bocca. Nella bocca compaiono piccole ulcere e talvolta si verifica un aumento della salivazione. Il trattamento e la diagnosi devono essere effettuati solo da un veterinario.
Sintomi della peste.

I sintomi frequenti che si verificano con la peste sono brividi improvvisi e improvvisi, aumento della temperatura corporea fino a 41 ° C, vertigini, debolezza generale, dolori muscolari, nausea. Inoltre, la coordinazione del movimento, dell'andatura e della parola negli animali è compromessa, il sistema nervoso soffre, mentre gli animali malati sono in uno stato di paura e ansia, gli animali iniziano a delirare.
Forme cliniche della malattia:
Localizzato: cutaneo e bubbonico;
Generalizzata: polmonare e settica.
Forma della pelle: al cancello d'ingresso si verificano alterazioni tissutali; nei casi più gravi possono emergere vescicole piene di essudato sieroso.
Forma bubbonica - Questo è un linfonodo ingrossato, la cui dimensione può variare da quella di una noce a quella di una mela. La pelle è lucida e rossa con una tinta cianotica, la palpazione è dolorosa. Il 4 ° giorno, il bubbone si ammorbidisce e appare una fluttuazione, il 10 ° giorno si apre il focolaio linfatico e si forma una fistola (un canale che collega gli organi cavi tra loro o con l'ambiente esterno) con ulcerazione. La forma bubbonica può in qualsiasi momento causare la generalizzazione del processo e progredire sia in complicanze settiche batteriche secondarie che in complicanze polmonari secondarie.
Forma settica. Nella forma settica primaria della peste, i microbi penetrano attraverso la pelle o le mucose. Sintomi primari della malattia: aumento della temperatura dell'animale, l'animale avverte mancanza di respiro, aumento del polso e l'animale inizia a delirare. Gli animali spesso sviluppano eruzioni cutanee. Se noti questi sintomi nel tuo animale domestico, cerca immediatamente l'aiuto di un veterinario, poiché se non trattato entro 3-4 giorni può verificarsi la morte.
Forma polmonare. La forma polmonare è caratterizzata dallo sviluppo di focolai di infiammazione nei polmoni come sintomi principali della peste. La forma polmonare della peste inizia a distruggere le funzioni delle vie respiratorie. Gli animali sviluppano quindi secrezioni dagli occhi e dal naso, che alla fine diventano purulente. Durante il processo di secrezione purulenta, i passaggi nasali degli animali si chiudono. Negli animali si verifica un gonfiore della mucosa nasale, che impedisce all'animale di respirare normalmente, e le inalazioni e le esalazioni sono sibili e negli animali le palpebre iniziano ad aderire dal pus. C'è una tosse debole con espettorato. Con questa malattia, gli animali spesso sviluppano bronchite e talvolta polmonite.
Se noti uno qualsiasi dei sintomi, contatta immediatamente il veterinario. Il veterinario farà una diagnosi accurata e prescriverà un trattamento per il tuo amato animale domestico.
Inviare il tuo buon lavoro nella knowledge base è semplice. Utilizza il modulo sottostante
Studenti, dottorandi, giovani scienziati che utilizzano la base di conoscenze nei loro studi e nel loro lavoro ti saranno molto grati.
Pubblicato su http://www.allbest.ru
Prevenzione delle malattie animali virali e infettive
Nelle cliniche moderne, tra cui LLC Vetprofi e Fauna, cani e gatti vengono vaccinati contro le malattie più pericolose. La cosa più importante (soprattutto nella regione di Mosca, in prossimità dei parchi forestali dove vivono volpi e ricci), è forse la vaccinazione contro la rabbia. Si vaccinano inoltre: i cani contro il cimurro, l'epatite, l'enterite, l'adenovirus, la parainfluenza e la leptospirosi; gatti da panleucopenia, calicivirosi, rinotracheite, clamidia.
Se necessario, gli animali vengono vaccinati contro la dermatofitosi (licheni, tricofitosi, microsporia, favus). La vaccinazione contro il lichene viene somministrata a cani e gatti a partire da 1,5 mesi di età. A scopo profilattico, la vaccinazione viene eseguita 2 volte con un intervallo di 10-14 giorni. I veterinari consigliano vivamente di vaccinare cani e gatti contro i licheni, soprattutto se in famiglia ci sono bambini piccoli. La malattia colpisce più spesso cani e gatti che hanno contatti con altri animali. I gatti portati in campagna in estate devono essere vaccinati in primavera almeno un mese prima del trasferimento.
Virale di basee contagiosomalattie animali riscontratevisitare cliniche veterinarie
Rabbia. La rabbia è una malattia infettiva causata da un virus trasmesso attraverso la saliva quando viene morso da animali malati. Sono particolarmente colpiti cani e gatti, nonché animali selvatici (volpi, ecc.). L'infezione è possibile anche attraverso il contatto della saliva infetta con la pelle e le mucose che presentano ferite, graffi, ecc.
L'agente eziologico - Il virus della rabbia appartiene alla famiglia Rhabdovindae, al genere Lyssavirus, che comprende altri 6 virus correlati isolati da pipistrelli e altri animali in varie regioni del mondo (pipistrello Lagos, virus Mokola, virus Duvenhage, virus del pipistrello europeo, virus del pipistrello australiano virus). Il virus della rabbia è grande, contiene RNA a filamento singolo e ha due antigeni. S - comune a tutti i rabdovirus e V - superficiale, responsabile della formazione dell'immunità. Esistono virus della rabbia “selvaggia” (“di strada”), altamente patogeni per l'uomo e gli animali a sangue caldo, e un virus fisso ottenuto da L. Pasteur adattando il virus del coniglio selvatico. Non è patogeno e non viene escreto nella saliva. Il virus della rabbia è termolabile, viene distrutto a una temperatura di 60 ° C dopo 5-10 minuti, durante l'ebollizione - dopo 2 minuti, ma è resistente alle basse temperature. Inattivato da soluzioni disinfettanti di acidi e alcali, relativamente resistente al fenolo e allo iodio. Il virus si replica su molte colture polmonari, ma perde la sua citopatogenicità. La rabbia è un'infezione zoonotica alla quale sono sensibili tutte le specie di animali selvatici e domestici e l'uomo. Nell'epizootologia dell'infezione si distingue una rabbia di tipo naturale e antropourgica. I principali serbatoi del virus in natura sono i predatori canini e altri carnivori: lupi, volpi, cani procione, sciacalli, volpi artiche, puzzole, coyote manguste e pipistrelli. Il virus viene rilasciato dal corpo degli animali malati attraverso la saliva.
La forma violenta della rabbia è caratterizzata da cambiamenti nel comportamento dei cani. I cani sono depressi, cercano di nascondersi, non rispondono al richiamo del proprietario o sono restii ad avvicinarsi. In un'altra parte dei cani, al contrario, appare un maggiore affetto. Tendono a leccare le mani e il viso del proprietario. Tutti i cani malati hanno difficoltà a prendere cibo e acqua e quindi, a causa della paralisi muscolare, non sono completamente in grado di deglutire, la mascella inferiore si abbassa, la saliva scorre dalla bocca e appare lo strabismo. Quindi si verifica un'eccitazione generale (convulsioni), l'appetito è distorto (i cani rosicchiano e ingoiano trucioli di legno e altri oggetti non commestibili). I cani tendono a scappare e a mordere animali e persone (aggressione). L'eccitazione e l'aggressività sono sostituite da depressione generale, apatia e paralisi degli arti posteriori e della coda. Il 6-11 giorno gli animali muoiono.
Nella forma silenziosa (paralitica) della rabbia, non si osservano agitazione e aggressività. C'è paralisi muscolare, accompagnata da difficoltà a deglutire e sbavare. C'è il sospetto che il cane si sia soffocato con un osso. L'aumento della paralisi e la perdita di forza nel 2-4o giorno portano alla morte.
Le misure preventive consistono nel rispetto rigoroso delle regole di detenzione dei cani stabilite dalle autorità locali, non consentendo loro di essere lasciati incustoditi (roaming) anche per un breve periodo. Registrare tempestivamente i cani presso la stazione veterinaria locale e consegnarli per le vaccinazioni preventive annuali contro la rabbia. I cuccioli vengono vaccinati a partire dai 3 mesi di età.
Qualsiasi caso di morso di un cane da parte di animali selvatici (volpi, ecc.), cani e gatti, nonché se si sospetta che il cane abbia la rabbia, deve essere immediatamente segnalato al veterinario che serve la località, all'istituto medico e alla polizia. . È necessario isolare in modo affidabile gli animali sospettati di rabbia, morsi da cani randagi o animali selvatici. In futuro, seguire rigorosamente le istruzioni degli specialisti veterinari presso la stazione veterinaria regionale.
Malattie del cane
Peste dei carnivori. Una malattia virale altamente contagiosa dei carnivori (morbo di Carré) è caratterizzata da febbre, infiammazione catarrale acuta delle mucose, esantema cutaneo, polmonite e gravi danni al sistema nervoso.
Patogeno. Un virus RNA della famiglia dei paramixovirus, è strettamente correlato al virus del morbillo umano e al virus della peste bovina. L'agente patogeno è resistente a fattori esterni: alla luce del sole rimane attivo fino a 10-14 ore, a una temperatura di meno 20 ° C rimane negli organi degli animali morti fino a 6 mesi, nel sangue - fino a 3 Nelle secrezioni di animali malati (feci, muco) all'esterno in un ambiente alla temperatura di 4° C, il virus persiste per 7-11 giorni, a 100° C muore istantaneamente (V.N. Syurin et al., 1998 ).
Resistenza ai disinfettanti. In termini di resistenza, il virus appartiene al 2° gruppo di agenti patogeni di malattie infettive.
Dati epizootologici. Vari carnivori sono sensibili al virus della peste: cani, lupi, volpi, sciacalli, volpi artiche, furetti, zibellini, ecc. Gli animali giovani sono i più sensibili. L'immunità colostrale delle madri immuni protegge i cuccioli dalla malattia fino a 2-3 mesi di età.
Esiste una relativa resistenza alla peste nei cani di razza, nei terrier e viceversa, una maggiore suscettibilità: husky, pastori tedeschi, barboncini, collie, bull terrier, pechinese, ecc. Tuttavia, questa predisposizione della razza non è stata dimostrata in un esperimento scientifico .
La fonte dell'agente infettivo sono gli animali malati e guariti, che rilasciano il virus nell'ambiente esterno attraverso le secrezioni dal naso, dagli occhi, dalla saliva, dalle urine e dalle feci. I cani che si sono ripresi dalla peste e non presentano segni clinici diffondono il virus nell'ambiente esterno fino a 3 mesi. Il serbatoio del virus in natura sono soprattutto i carnivori selvatici, ma in alcuni casi possono essere presenti anche altre specie animali. La peste dei carnivori viene registrata in qualsiasi periodo dell'anno, ma più spesso in primavera e autunno.
La mortalità può essere dell'80-90%.
Infezione. La peste dei carnivori è caratterizzata principalmente da 2 metodi di infezione (penetrazione dell'agente infettivo nel corpo): orale e aerogeno (respiratorio). I cani si infettano attraverso il contatto diretto o indiretto con animali malati o guariti, attraverso oggetti ambientali infetti (mangimi, acqua, aria, escrementi di animali malati e oggetti vari per la loro cura).
Il periodo di incubazione della malattia è di 3-7 giorni, anche se in alcuni casi può raggiungere i 2-3 mesi.
Patogenesi. L'introduzione iniziale del virus avviene solitamente attraverso le mucose e i linfonodi (sottomandibolari, bronchiali, ecc.), dove si moltiplica e poi si diffonde attraverso il sangue e la linfa in tutto il corpo, provocando numerose alterazioni patologiche in vari organi e tessuti. In questo caso, si verifica una sconfitta generale e onnicomprensiva dei sistemi più importanti del corpo: respiratorio, immunitario, circolatorio, linfatico, nervoso, digestivo, endocrino, ecc. Pertanto, a nostro avviso, la peste dei carnivori deve essere considerata come una malattia multisistemica dell'intero organismo e non dei suoi singoli sistemi e organi.
Con la peste dei carnivori, tenendo conto delle proprietà specifiche dell'agente patogeno, si osservano danni significativi al tessuto linfatico e, di conseguenza, l'esaurimento del sistema immunitario negli animali malati. Pertanto, negli animali guariti dalla peste (cani convalescenti) si sviluppano stati di immunodeficienza persistente (immunodeficienze secondarie).
La peste dei carnivori si manifesta spesso in associazione con altri agenti patogeni: enterite da adenovirus, corona e parvovirus, epatite infettiva, ecc. Nelle forme gravi di peste si osservano infezioni batteriche secondarie (cocchi, salmonella, ecc.).
Sintomi Il cimurro è caratterizzato da un quadro clinico della malattia molto diversificato, determinato da molti fattori: la virulenza (grado di patogenicità) di un determinato ceppo patogeno, la presenza o l'assenza di infezioni associate e secondarie, nonché le caratteristiche fisiologiche delle infezioni infette animali (lo stato del sistema immunitario, la presenza di altri fattori patologici nel corpo, comprese le malattie non trasmissibili, ecc.). Innanzitutto, la peste colpisce le mucose del tratto respiratorio superiore, dell'apparato digerente e degli occhi, causando infiammazione catarrale acuta e febbre.
La peste può manifestarsi in modo iperacuto (fulmineo), acuto, subacuto, cronico, nonché tipicamente e atipico.
Il decorso iperacuto della malattia è caratterizzato da un improvviso aumento della temperatura corporea fino a 40-41°C, depressione significativa dell'animale, rifiuto di nutrirsi, rinite acuta e congiuntivite. Poi improvvisamente inizia un coma e l'animale muore il 2-3o giorno.
Il decorso acuto e subacuto della malattia dura 2-4 settimane ed è caratterizzato da un'ampia varietà di sintomi. Nei cani adulti con un forte sistema immunitario, la peste può manifestarsi solo come febbre e depressione delle condizioni generali; in questi casi la malattia dura 3-5 giorni e termina con la guarigione.
Molti autori e veterinari, a seconda della localizzazione e della gravità dei segni clinici più caratteristici, distinguono: forme polmonari, intestinali, nervose, cutanee e miste della malattia (V.A. Chizhov et al., 1992; N.A. Masimov , A.I. Belykh, 1996 ; I.A. Bakulov, 1997, ecc.). Tuttavia, come abbiamo già notato, la peste dei carnivori è caratterizzata da danni multisistemici al corpo, pertanto la suddetta divisione della malattia in forme separate è condizionata.
Nonostante tutta la varietà dei sintomi, il periodo clinico (il culmine della malattia) inizia nella maggior parte degli animali, di regola, con un forte aumento della temperatura corporea di 1-3°C e un'infiammazione catarrale acuta delle mucose dell'apparato respiratorio , digestivo, genito-urinario e altri sistemi del corpo. Nella forma acuta della malattia, la febbre dura 2-3 giorni, nella forma subacuta (febbre moderata) - 3-5 giorni; poi la temperatura scende leggermente, ma rimane di 0,5°C sopra la norma (in diverse razze di cani può essere 39,5-40,5°C).
Durante questo periodo, gli animali malati sono letargici, per lo più si sdraiano, rifiutano il cibo, ma bevono acqua. I cani sperimentano forti brividi e depressione generale.
Le mucose degli occhi e del tratto respiratorio superiore sono arrossate, molto gonfie, compaiono prima le mucose e poi abbondanti secrezioni mucopurulente dagli occhi e dal naso, che aderiscono gradualmente alle palpebre e ostruiscono le aperture nasali. La pelle del naso è secca, su di essa si formano crepe e rughe profonde, ricoperte da croste secche e purulente. I cani sbuffano, starnutiscono spesso e si grattano il naso con le zampe. La respirazione diventa difficoltosa (sibilo o respiro sibilante), rapida ed è di 40-60 respiri/min nei cani di taglia grande e di 60-80 in quelli di piccola taglia. Anche la frequenza cardiaca negli animali malati aumenta in modo significativo e nei cani di taglia grande è di 100-130 battiti al minuto e in quelli di piccola taglia di 130-170 (nei cuccioli queste cifre sono corrispondentemente molto più alte).
Successivamente, se gli animali hanno un'elevata resistenza naturale, la malattia assume un decorso benigno e i cani guariscono gradualmente. Con una ridotta resistenza naturale degli animali, se il loro trattamento non viene effettuato, aumenta l'infiammazione catarrale acuta delle mucose e di altre membrane, causando profondi cambiamenti patologici nel corpo e la malattia passa alla fase successiva dello sviluppo clinico. È in questa fase, a seconda della virulenza dell'agente patogeno e della sua localizzazione, della reattività individuale, immunologica e legata all'età dell'organismo, nonché della presenza delle suddette infezioni associate e (o) secondarie, che nuove - Si osservano segni clinici “secondari” della malattia, che si manifestano nell'elenco Di seguito sono riportate le forme condizionali.
Polmonare (respiratorio) - caratterizzato da gravi danni al sistema respiratorio: prima il tratto respiratorio superiore e poi quello inferiore. In questo caso si sviluppano costantemente rinite, tracheite, bronchite, polmonite o le loro forme miste (catarro acuto del tratto respiratorio superiore, tracheobronchite, broncopolmonite), che possono essere diagnosticate con un'attenta auscultazione e percussione.
Enterite da parvovirus. Una malattia virale altamente contagiosa dei cani, caratterizzata principalmente da enterite emorragica acuta, disidratazione, leucopenia e miocardite.
Patogeno. Un virus a DNA appartenente alla famiglia Parvoviridae, genere Parvovirus. Esistono due tipi di parvovirus canino (PVV): PVS-1 e PVS-2. Il più pericoloso è il patogeno PVA-2, che causa l'enterite acuta da parvovirus nei cani. In termini di proprietà immunogeniche, il PVA-2 è vicino agli agenti causali della panleucopenia nei gatti e dell'enterite nei visoni. L'agente patogeno PVA-2 è molto stabile nell'ambiente e a temperatura ambiente può persistere negli oggetti infetti per 6 mesi (P.F. Suter, 1994, 1998; P.M. Gaskell, M. Bennett, 1996, 1999).
Resistenza ai disinfettanti. Il virus appartiene al 2o gruppo di resistenza degli agenti patogeni delle malattie infettive (vedi Tabella 1).
Dati epizootologici. Come malattia indipendente, l'enterite da parvovirus canino è stata registrata per la prima volta nel 1976 in Belgio, nel 1978 negli Stati Uniti e poi nel 1978-1981. - in Australia, Canada, Inghilterra, Italia, Francia, ecc. In Russia, la malattia è stata registrata per la prima volta intorno al 1983. Attualmente, l'enterite da parvovirus canino è una delle 5 malattie infettive più comuni dei cani in Russia.
Fonte dell'agente patogeno. È importante notare che l'enterite virale (gastroenterite) nei cani può essere causata non solo dall'agente patogeno PVS-2, ma anche da altri virus: coronavirus, rotavirus, virus del cimurro, epatite infettiva, infezioni miste, ecc. Ad esempio, in Australia durante un esame autoptico sono stati rinvenuti cani affetti da enterite: nel 30% dei casi - parvovirus canino, nel 2,6% - virus del cimurro e nel 2% - coronavirus canino (P.F. Suter, 1994, 1998).
Infezione. Si verifica principalmente attraverso la via fecale-orale attraverso cibo e acqua infetti da PVA, nonché attraverso il contatto - quando si annusano e leccano animali direttamente malati o oggetti ambientali da essi infetti.
Il periodo di incubazione dell'enterite da parvovirus varia solitamente da 4 a 10 giorni e nei cuccioli di 1-2 mesi è di 1-3 giorni.
Patogenesi. I cani di qualsiasi età sono suscettibili alla malattia, ma i cuccioli di età compresa tra 2 e 16 settimane sono più suscettibili alla malattia. Ciò è spiegato dal fatto che l'agente patogeno PVS-2 si moltiplica particolarmente rapidamente nelle cellule con un alto livello di mitosi (la forma principale di divisione cellulare) e nei cuccioli fino a 4 settimane di età le cellule del miocardio si dividono attivamente e successivamente - cellule del tessuto linfoide, del midollo osseo e dell'epitelio della cripta intestinale (R. Janson et al., 1983). La malattia si osserva più spesso nei cuccioli ottenuti da cagne non vaccinate.
Sintomi A seconda della gravità dei segni clinici, si suddividono convenzionalmente tre forme principali della malattia: cardiaca, intestinale e mista.
La forma cardiaca (miocardite) è caratterizzata principalmente da un danno acuto al miocardio (miocardite virale) e si osserva solitamente nei cuccioli di età compresa tra 2 e 8 settimane. La malattia arriva all'improvviso e progredisce alla velocità della luce. I cuccioli rifiutano cibo e acqua e non possono allattare da soli dalla madre. Negli animali malati si osservano grave debolezza, mancanza di respiro e insufficienza cardiovascolare; il polso è aritmico, con riempimento debole. I cuccioli muoiono entro 24-48 ore in stato di collasso.
La forma intestinale (intestinale) è la forma più tipica di enterite da parvovirus. Di solito si manifesta in forme acute, talvolta subacute. I principali segni della malattia sono il vomito prolungato e incontrollabile, ripetuto più volte nell'arco di diversi giorni, il completo rifiuto del cibo (anoressia) e dell'acqua. Va sottolineato che, a differenza di altre malattie virali intestinali (cimurro, epatite infettiva, ecc.), nell'enterite da parvovirus i cani non bevono acqua, latte e altri liquidi per 1-3 giorni. Ciò è dovuto a estese lesioni catarrali o emorragiche dell'intestino tenue e crasso, che causano forti dolori.
La diarrea (diarrea) appare negli animali 1-3 giorni dopo l'inizio del vomito e dura da 2 a 10 giorni.
Le feci sono inizialmente mucose, poi diventano acquose, sanguinolente con un caratteristico odore fetido. Il vomito incontrollabile e la diarrea prolungata causano una grave disidratazione del corpo e, di conseguenza, profondi disturbi dell'omeostasi (la relativa costanza dinamica dell'ambiente interno e la stabilità delle funzioni fisiologiche di base del corpo). Negli animali malati si notano grave debolezza, esaurimento significativo, insufficienza cardiovascolare e polmonare, ecc.
La forma mista (combinata) della malattia è caratterizzata da varie lesioni dei sistemi cardiovascolare, digestivo e respiratorio del corpo. Si osserva negli animali con un sistema immunitario indebolito, nei cuccioli ottenuti da cagne non vaccinate, nonché in presenza di infezioni associate (adeno, corona, rotavirus, ecc.). I segni clinici della malattia sono molto diversi. Oltre ai sintomi sopra descritti, si nota anche l'infiammazione catarrale delle vie respiratorie superiori e inferiori.
La temperatura corporea nella forma acuta della malattia nella fase iniziale sale spesso a 40-41,5 ° C, rimane a questo livello per 2-3 giorni, quindi si normalizza gradualmente (prognosi favorevole) o scende rapidamente sotto i 37 ° C (letale o prognosi sfavorevole). previsione).
I parametri ematologici nei primi 2-5 giorni sono caratterizzati da grave leucopenia (2-4 mila in 1 mm3 di sangue), nonché da una diminuzione dei monociti. Successivamente, con una prognosi favorevole, si osserva uno spostamento del numero dei leucociti a sinistra, una leucocitosi significativa (oltre 20mila in 1 mm3) e una monocitosi.
Diagnosi. Stabilito sulla base di dati epidemiologici, segni clinici della malattia, cambiamenti patologici e risultati dei test di laboratorio. Questi ultimi sono estremamente importanti nella diagnosi differenziale di varie infezioni virali, batteriche e altre infezioni intestinali. Per la diagnosi di laboratorio dell'enterite da parvovirus nei cani, vengono utilizzati metodi ELISA, analisi a raggi X, raggi X, microscopia elettronica (feci di animali malati), ecc.
Nella diagnosi differenziale dovrebbero essere escluse l'enterite da corona e da rotavirus, la forma intestinale della peste, l'epatite infettiva, la campilobatteriosi, la giardiasi, la salmonellosi e la gastroenterite acuta non contagiosa.
Previsione. In caso di disturbi irreversibili dell'omeostasi, gli animali muoiono 2-4 giorni dopo l'insorgenza della malattia. Con un decorso più lungo della malattia (forma subacuta) e un trattamento adeguato, aumenta la probabilità di recupero.
Nella forma iperacuta della malattia, la mortalità tra i cuccioli in alloggi di gruppo può raggiungere l'80-95%, in alloggi individuali (stanze) - 50-60% e nella forma acuta, rispettivamente 30-50% e 20-30%. .
Trattamento. A causa della varietà delle manifestazioni dei segni clinici della malattia, è necessario effettuare un trattamento complesso individuale degli animali.
Sulla base dell'analisi e della sintesi dei dati pubblicati da vari autori nazionali e stranieri, nonché della nostra ricerca a lungo termine, abbiamo sviluppato un sistema completo per il trattamento dei piccoli animali domestici affetti da enterite virale intestinale (gastroenterite). Questo complesso sistema di trattamento, testato con successo su un gran numero di cani e gatti, comprende terapia etiotropica, patogenetica, sintomatica e sostitutiva (vedi più in dettaglio “Peste dei carnivori”, trattamento).
Per la terapia etiotropica degli animali malati, a seconda dell'accuratezza della diagnosi, vengono utilizzati i seguenti mezzi:
Per una diagnosi preliminare (sintomatica, clinica), quando non vi è fiducia nella diagnosi differenziale della malattia, si consiglia di utilizzare sieri iperimmuni polivalenti - contro l'enterite da parvovirus e il cimurro; contro la peste, le infezioni da parvovirus e l'epatite virale dei carnivori, nonché le immunoglobuline polivalenti;
Per una diagnosi finale (accurata) stabilita sulla base di studi clinici, di laboratorio e di altro tipo, è necessario utilizzare principalmente immunoglobulina monovalente e (o) siero iperimmune monovalente contro l'enterite da parvovirus canino.
Si consiglia di utilizzare i prodotti specifici specificati di produzione nazionale (ZAO Vetzverotsentr, NPO Narvak, ecc.) nella fase iniziale della malattia 1-2 volte al giorno (a seconda della gravità della malattia) per 1-3 giorni in secondo le istruzioni per la loro applicazione. In presenza di infezioni miste sono necessarie iniezioni di antibiotici sistemici per 3-7 giorni.
La terapia patogenetica comprende i seguenti metodi e mezzi di base:
La paraimmunizzazione è l'uso di antigeni non specifici o induttori di paraimmunità per stimolare l'immunità non specifica. A questo scopo vengono utilizzati immunomodulatori di nuova generazione: licopide, poliossidonio, vegetariano, (vitan), galavit, ribotan e altri (vedi più in dettaglio “Peste dei carnivori”, trattamento). Va notato che gli immunomodulatori licopide, poliossidonio e alcuni altri sono anche buoni disintossicanti, il che è molto importante per le infezioni virali intestinali;
Reidratazione - somministrazione di soluzioni fisiologiche acqua-saline; soluzioni arricchite con glucosio, vitamine e altre sostanze che compensano la disidratazione dell'organismo. A questo scopo viene utilizzato principalmente il metodo di somministrazione parenterale. Per la somministrazione endovenosa si consiglia di utilizzare le seguenti soluzioni bilanciate di sale marino prodotte in Russia dall'industria medica: acesolo, disolo, trisolo, lattasolo, quartasolo, ecc. Per la somministrazione sottocutanea si consiglia di utilizzare la seguente soluzione, che può essere preparata immediatamente al momento del bisogno: in una bottiglia ermeticamente chiusa di soluzione isotonica di cloruro di sodio (0,9%) con un volume di 200 ml (chiusura sterile industriale!), introdurre 20 ml di soluzione di glucosio al 40% e 4 ml di soluzione di acido ascorbico al 5%. Somministrare per via sottocutanea in ragione di 30-100 ml di soluzione per 1 kg di peso animale al giorno;
La disintossicazione è l'uso di mezzi speciali per neutralizzare le sostanze tossiche nel corpo ed eliminarle. A questo scopo vengono utilizzati hemodez, quartasol, reopolyglucin, ecc.;
La desensibilizzazione è l'uso di mezzi speciali per ridurre la sensibilità del corpo a determinati antigeni, ad esempio alle proteine estranee dei sieri iperimmune, ecc. A questo scopo vengono solitamente utilizzati agenti desensibilizzanti non specifici (antistaminici, ecc.);
Stimolanti generali e preparati multivitaminici vengono utilizzati per aumentare la resistenza generale del corpo, ripristinare il normale metabolismo, ecc.
Malattie del gatto
Panleucopenia felina. La panleucopenia felina (enterite da parvovirus, gastroenterite infettiva, cimurro, ecc.) è una malattia virale acuta altamente contagiosa dei mammiferi della famiglia dei gatti (tigri, leopardi, ghepardi, gatti, ecc.), mustelidi (visoni, furetti), procioni ( procioni, nasi) e viverridi, caratterizzati da danni al tratto gastrointestinale degli animali e una significativa diminuzione del numero totale di leucociti nel sangue.
Patogeno. Un virus a DNA della famiglia dei parvovirus (Parvoviridae), sierologicamente vicino all'agente eziologico dell'enterite da parvovirus nei cani e nei visoni. Nell'ambiente, il virus è abbastanza stabile e mantiene la sua virulenza negli oggetti infetti per più di un anno.
In termini di resistenza ai disinfettanti, l'agente patogeno appartiene al gruppo 2.
Dati epizootologici. La malattia si verifica in molti paesi in America, Europa e Asia. Molto spesso, si osservano malattie animali di massa in estate e nel tardo autunno, a causa delle dinamiche stagionali del tasso di natalità dei gattini. La panleucopenia è caratterizzata dalla presenza latente del virus. Anche gli insetti succhiatori di sangue e le zecche contribuiscono alla diffusione della malattia.
Infezione. L'infezione più tipica è quella oro-fecale, ma talvolta è possibile anche l'infezione oro-nasale.
Il periodo di incubazione è di 2-12 giorni.
Patogenesi. Il virus della panleucopenia, dopo essere stato introdotto nell'organismo dell'animale, colpisce principalmente l'epitelio della mucosa del tratto gastrointestinale (epitelio del bordo intestinale), il tessuto linfoide e il midollo osseo, poiché il virus è ternario ai tessuti e agli organi con la maggiore densità attività mitotica (zone di rapida divisione cellulare). Successivamente, il virus infetta i linfociti nel tessuto linfoide e le cellule staminali dei leucociti nel midollo osseo, provocando una grave panleucopenia, il cui livello determina principalmente la gravità della malattia e la sua prognosi. Allo stesso tempo, la formazione dei globuli rossi (eritropoiesi) rimane a un livello normale.
Sintomi La malattia può manifestarsi in forme iperacuta, acuta e subacuta. Il decorso iperacuto della malattia si osserva principalmente nei piccoli gattini di età compresa tra 1 e 3 mesi, quando già perdono l'immunità colostrale. La malattia inizia all'improvviso, i gattini smettono di succhiare, rifiutano il cibo, squittiscono costantemente e si stancano rapidamente. La morte degli animali avviene entro 1-2 giorni.
Il decorso acuto della malattia è caratterizzato da depressione generale dell'animale, anoressia, vomito e aumento della temperatura corporea fino a 40-41°C. Gli animali hanno molta sete, ma non bevono acqua. Dopo 1-3 giorni appare la diarrea, le feci sono prima acquose-biliose e successivamente mucose miste a sangue e (o) fibrina. Si notano forti dolori nella zona addominale e gonfiore. Se il decorso della malattia è favorevole, i gatti guariscono in 5-7 giorni.
Con un decorso sfavorevole della malattia si verifica una significativa disidratazione del corpo, uno squilibrio elettrolitico e una forte diminuzione dei leucociti nel sangue (500-1000 per 1 mm3). La temperatura corporea può scendere fino a 37-38° C, segno diagnostico di prognosi sfavorevole. Si notano anche depressione generale dell'attività cardiovascolare, bradicardia e (o) aritmia. In caso di infezione secondaria (secondaria), aumenta la probabilità di morte.
Il decorso subacuto della malattia è caratterizzato da segni clinici simili a quelli del decorso acuto, ma sono meno pronunciati e si sviluppano gradualmente in un periodo di tempo più lungo - 7-14 giorni.
Diagnosi. La malattia viene diagnosticata sulla base dei segni clinici e dei risultati degli studi virologici ed ematologici. Per gli studi virologici, dai gatti malati vengono prelevati siero del sangue, tamponi nasofaringei, urina e feci. Per determinare l'agente eziologico della panleucopenia nei gatti, si consiglia di utilizzare il "Kit per la diagnosi dell'enterite da parvovirus dei cani, dei visoni e della panleucopenia dei gatti nella reazione di inibizione dell'emoagglutinazione" (NPO "Narvak"). È anche possibile utilizzare kit da laboratorio per rilevare gli antigeni dell'enterite del parvovirus canino (P.M. Gaskell, M. Bennett, 1996-1999).
Nella diagnosi differenziale è necessario escludere la gastroenterite non contagiosa, la toxoplasmosi, il linfosarcoma e l'avvelenamento.
Previsione. Nella forma iperacuta è solitamente letale, nella forma acuta non complicata è favorevole, nella panleucopenia complicata da infezioni secondarie è sfavorevole o letale. La mortalità nella forma acuta è del 25-75%.
Trattamento. Per la panleucopenia felina, come per altre malattie infettive di piccoli animali domestici, viene effettuata una terapia etiotropica, patogenetica e sintomatica complessa individuale.
Terapia etiotropica. Come trattamenti specifici nella fase iniziale della malattia, si raccomanda l'uso di globuline contro la panleucopenia felina e altre malattie infettive: Vitafel, Globfel (contro panleucopenia, rinotracheite infettiva, calicivirus felino e clamidia), nonché i corrispondenti sieri iperimmune, che sono usato 2-3 volte secondo le istruzioni.
Terapia patogenetica. Per attivare l'immunità umorale e cellulare si consiglia l'uso di immunomodulatori di nuova generazione (vedi “Dermatofitosi del cane e del gatto”).
Per mantenere le funzioni del sistema cardiovascolare, è necessario iniettare soluzioni di sulfocanfocaina in una dose di 0,3-0,5 ml (per un animale adulto) 1-2 volte al giorno durante il corso del trattamento.
Come terapia di mantenimento, la somministrazione sottocutanea della seguente soluzione ha un buon effetto: 1 ml di soluzione Essentiale Forte (per iniezione endovenosa) per 10 ml di soluzione di glucosio al 5% o 10 ml di soluzione salina (per iniezione).
Per sopprimere il vomito vengono utilizzati antiemetici come cerucal, raglan, metoclopromide, ecc. Poiché la somministrazione orale di farmaci ai gatti è difficile, per le infezioni secondarie si raccomandano iniezioni intramuscolari di antibiotici ad ampio spettro (amoxicillina insieme a clavulanato, cefalosporine, ecc.), che aiutano a sopprimere le infezioni batteriche secondarie e il processo infiammatorio nei reni.
Per ripristinare l'equilibrio elettrolitico, è necessario effettuare una reidratazione intensiva: somministrazione sottocutanea e (o) endovenosa di soluzioni isotoniche di Ringer - lattato, trisolo, quadrosolo, ecc. Nella fase di recupero (dopo la cessazione della diarrea), un buon trattamento terapeutico L'effetto si osserva con la somministrazione rettale di 50 ml della seguente composizione di soluzione terapeutico-nutriente: 40 ml di soluzione salina, 8 ml di soluzione di glucosio al 40%, 1,5 ml di soluzione di acido ascorbico (per iniezione) e 0,5 ml di soluzione di sulfocanfocaina (per iniezione). La soluzione specificata viene somministrata 2 volte al giorno con un intervallo di 12 ore fino al ripristino della normale alimentazione.
Terapia sostitutiva. Come agente antinfiammatorio e antimicrobico, puoi somministrare una soluzione di vino rosso secco per via orale in ragione di 5 ml (cucchiaino) per 20 ml di acqua bollita.
Allo stesso tempo, si raccomanda l'uso quotidiano di multivitaminici con microelementi, nonché la somministrazione intramuscolare di vitamina A, poiché la sua carenza riduce l'attività del sistema immunitario e i gatti non sono in grado di sintetizzare la vitamina A dal carotene. È possibile utilizzare speciali alimenti rigenerativi bilanciati dietetici (cibo in scatola) offerti da noti produttori.
La terapia sintomatica ha lo scopo di alleviare la sofferenza dell'animale. A questo scopo vengono utilizzati antidolorifici e antispastici, tra cui drotaverina cloridrato (noshpa), pa-pazol, ecc.
Alimentazione. Considerando il danno significativo alla mucosa del tratto gastrointestinale, nonché ai reni, è estremamente importante la dietoterapia veterinaria durante il periodo di recupero degli animali, che prevede l'alimentazione dell'animale con mangime liquido naturale e facilmente digeribile, vale a dire: prodotti freschi a base di acido lattico; brodo di riso con aggiunta di albumi termotrattati; zuppe di purea di cereali e verdure con l'aggiunta graduale di carne macinata bollita.
Immunità per questa malattia è solitamente di 3-4 anni. I gatti convalescenti hanno titoli molto elevati di anticorpi neutralizzanti il virus.
Durante l'autopsia di animali morti, si nota un esaurimento generale e si nota un'infiammazione catarrale con emorragie multiple e puntiformi sulla mucosa dello stomaco e dell'intestino. Da animali morti vengono prelevati campioni di milza, reni, intestino crasso e linfonodi mesenterici. Nei reni si riscontrano vari stadi di nefrite e pielonefrite.
Prevenzione. Per l'immunoprofilassi attiva sono ampiamente utilizzati vaccini monovalenti nazionali ed esteri contro la panleucopenia felina, nonché vaccini associati contro la panleucopenia e altre malattie infettive: Multifel-4, Parvovaccarnivorum (Russia), Vacciket, Quadrikat, Leukorifelin, Feliniffa (Francia), ecc.
La prevenzione generale è finalizzata al rispetto delle norme veterinarie, sanitarie e zooigieniche per l'alimentazione, la cura e il mantenimento dei gatti, nonché alla quarantena obbligatoria di tutti gli animali che entrano negli asili nido e nei rifugi. I locali destinati agli animali, nonché le attrezzature, le attrezzature e gli articoli per la cura sono soggetti a regolare disinfezione, disinfestazione e deratizzazione.
Leucemia virale (Leucemia viralis). La leucemia virale (leucemia) è una malattia virale zoonotica dei gatti, caratterizzata principalmente da danni al sistema emopoietico e neoplasie maligne dei tessuti linfoidi e mieloidi (linfosarcoma).
Patogeno. Un virus oncogeno di tipo C (oncornavirus) contenente RNA del genere Oncovirus C, famiglia di retrovirus (Retroviridae). Dal punto di vista sierologico e genetico si distinguono tre tipi di virus: A, B e C, e solo il sierotipo A è specifico per i gatti.
Resistenza ai disinfettanti. Il virus è instabile nell'ambiente esterno e non è resistente ai disinfettanti chimici (gruppo 1).
Dati epizootologici. La leucemia virale colpisce vari tipi di animali da fattoria e piccoli animali domestici, inclusi cani e gatti, nonché gli esseri umani. La leucemia virale felina (FVL) colpisce animali di varie fasce di età e razze, ma la suscettibilità alle infezioni diminuisce significativamente con l'età. I gatti tenuti in gruppo sono i più suscettibili al FLV (un'infezione persistente può essere osservata nel 30% degli animali). Tuttavia, l'infezione persistente nelle gatte in gravidanza e in allattamento provoca solitamente un'infezione simile in tutti i gattini di una determinata cucciolata. È importante notare che il FLV è una delle cause di morte più comuni nei gatti giovani (P.M. Gaskell, M. Bennett, 1996-1999).
L'infezione avviene principalmente attraverso l'alimentazione, ma anche nel periodo prenatale (in utero), intranatale (quando gli animali malati e sani vengono tenuti insieme) e attraverso il contatto indiretto (attraverso strumenti veterinari, ecc.). Non è possibile escludere una via di trasmissione (attraverso insetti ematofagi e zecche).
Il periodo di incubazione per VLK è lungo: da diversi mesi a 4 anni.
Patogenesi. Lo sviluppo della leucemia virale avviene molto lentamente, come un’infezione latente ed è dovuto alla predisposizione genetica dell’animale a questa malattia, nonché al deficit immunologico del suo organismo (immunodeficienze primarie o secondarie). Molto spesso, la malattia si manifesta dopo l'esposizione a fattori esogeni ed endogeni sfavorevoli, come cambiamenti improvvisi nelle condizioni di alimentazione e alloggio, ipotermia prolungata e altri disagi.
L'agente patogeno è tropicale per le cellule dei tessuti linfoidi ed emopoietici, quindi la sua replicazione primaria inizia nelle tonsille della faringe e successivamente si diffonde ad altri tessuti linfoidi, in particolare al midollo osseo, dove, sotto l'influenza del virus, si verifica la normale emopoiesi. viene interrotto e il tessuto tumorale cresce progressivamente (formazione di linfosarcoma). Di conseguenza, nel sangue degli animali malati compaiono un gran numero di leucociti immaturi (leucocitosi). Con l'ulteriore sviluppo del processo patologico, il virus VLK si trova nel latte, nella saliva, nelle urine e nelle feci di animali malati, che diventa un fattore importante nella trasmissione dell'agente infettivo.
Sintomi La leucemia virale nei gatti si manifesta principalmente in forme croniche e latenti. Nel decorso cronico della malattia si possono distinguere gli stadi prodromico, clinico e terminale. Gli animali malati spesso soffrono di anemia, diminuzione dell'appetito, depressione, disfunzione cardiaca e esaurimento graduale, nonché vari disturbi riproduttivi.
Questi ultimi si manifestano sotto forma di patologia della gravidanza (riassorbimento fetale, aborto) e di nascita di gattini morti o non vitali (sindrome del gattino appassito).
L'immagine del sangue mostra leucocitosi, uno spostamento significativo del numero dei leucociti a sinistra, una diminuzione del numero dei globuli rossi e una graduale diminuzione dell'ematocrito. A causa del fatto che lo stadio clinico della VLK è caratterizzato dallo sviluppo di varie forme di neoplasie maligne dei tessuti linfoidi e mieloidi, incluso prevalentemente il linfosarcoma, i sintomi della malattia sono determinati dalla loro localizzazione.
La forma latente (latente) non è accompagnata dallo sviluppo di segni clinici della malattia e non si manifesta per molto tempo (da diversi mesi a diversi anni), ma l'esposizione al disagio può intensificare notevolmente lo sviluppo della malattia.
Diagnosi. La malattia viene diagnosticata sulla base di studi clinici ematologici, sierologici, patologici e istologici. Per identificare specifici antigeni VPC, vengono utilizzati metodi di analisi immunoassorbente enzimatica (ELISA) e sistemi di test speciali.
Nella diagnosi differenziale sono escluse le malattie infettive acute e invasive dei gatti, che sono accompagnate da cambiamenti simili nel quadro ematico.
Previsione con leucemia virale felina, di regola, sfavorevole. La mortalità nel decorso cronico della malattia è elevata e la maggior parte dei gatti infetti muore entro 3-4 anni dall'infezione con il virus FLV.
Trattamento. La terapia etiotropica e patogenetica per la leucemia virale felina non è stata sviluppata. Un leggero effetto terapeutico può essere osservato con l'uso complesso di immunomodulatori (Galavit, ecc.) in combinazione con farmaci citotossici, tuttavia è necessario sviluppare un sistema di trattamento scientificamente fondato e stabilire dosaggi precisi.
Immunità in VLK non è stato studiato abbastanza. Molti gatti di età superiore ai 4-5 anni che hanno già avuto contatti con l'agente eziologico di questa malattia possono sviluppare un'immunità abbastanza stabile.
Cambiamenti patologici. Durante l'autopsia dei gatti morti, si notano esaurimento generale, ingrossamento dei linfonodi regionali e formazione di varie forme di linfosarcoma: timico, addominale, ecc.
Prevenzione. Per l'immunoprofilassi attiva della leucemia virale felina viene utilizzato il vaccino associato Lecat (Francia). La vaccinazione primaria dei gattini prevede un'iniezione due volte del vaccino all'età di 8-12 settimane. Ulteriori rivaccinazioni vengono effettuate ogni anno (vedere Tabella 3).
La prevenzione generale prevede il rigoroso rispetto delle norme veterinarie, sanitarie e zooigieniche per l'alimentazione e la custodia dei gatti, soprattutto negli asili nido e nei rifugi. La quarantena e l'ispezione degli animali appena arrivati vengono effettuate per almeno 3 mesi
Malattie respiratorie infettive (Morbum infectiosae respiratoria). Malattie respiratorie infettive dei gatti ( rinotracheite infettiva (herpesvirus)., calicivirus, naso che cola virale) è il nome generico di infezioni miste acute altamente contagiose, caratterizzate principalmente da infiammazione catarrale delle mucose delle vie respiratorie superiori, della cavità orale e della congiuntiva.
Patogeno. Le malattie respiratorie infettive dei gatti sono causate da uno o più agenti patogeni di natura virale e (o) batterica. Di primaria importanza eziologica sono il virus a-herpes contenente DNA (oc-herpesvirus) dei gatti e il calicivirus (calicivirus) dei gatti, nonché i patogeni batterici: Bordetella bronchiseptica (Bordetella bronchiseptica), clamidia (Chlamydia psittaci) e micoplasma (Mycoplasma ).
Gli agenti patogeni elencati sono caratterizzati da un certo tropismo per organi e tessuti specifici.
Pertanto, nei gatti i virus causano principalmente malattie degli organi respiratori (rinofaringe e bronchi).
La clamidia colpisce principalmente la congiuntiva e, in alcuni casi, gli organi respiratori. Bordetella bronchiseptica e micoplasmi possono agire come fattori eziologici indipendenti e agire anche come agenti causali di infezioni secondarie. Inoltre, altri agenti patogeni possono svolgere un ruolo nello sviluppo di queste malattie: reovirus, poxvirus e coronavirus felino, nonché stafilococchi, streptococchi, pasteurella e colibatteri (P.M. Gaskell, M. Bennett, 1996-1999).
Gli agenti patogeni virali di questo gruppo di infezioni sono generalmente instabili nell'ambiente esterno e persistono in un ambiente secco per non più di 1-2 giorni e in un ambiente umido fino a 10 giorni.
In termini di resistenza ai disinfettanti chimici, i patogeni virali appartengono principalmente al gruppo a bassa resistenza (gruppo 1) e i patogeni batterici al gruppo resistente (gruppo 2).
Dati epizootologici. Le malattie respiratorie infettive dei gatti sono diffuse in vari paesi del mondo. In Russia, questo gruppo di malattie respiratorie dei gatti ha iniziato a essere diagnosticato relativamente di recente.
Considerando che queste malattie si manifestano principalmente con segni clinici simili (un unico complesso di sintomi), viene attribuita un'importanza eccezionale all'isolamento e all'identificazione del principale agente eziologico della malattia per lo sviluppo di adeguate misure terapeutiche e preventive.
Il principale serbatoio di infezione sono i gatti malati o gli animali convalescenti che sono portatori del virus da molto tempo. Le epizoozie si osservano più spesso durante la detenzione in gruppo di animali (canili e ricoveri), nonché dopo eventi felinologici di massa (mostre, spettacoli riproduttivi, ecc.). Se tenuta in isolamento in casa, la malattia è relativamente rara. I gatti di tutte le età e razze sono suscettibili alla malattia, ma i gattini di età compresa tra 1 e 3 mesi sono i più sensibili. Le epidemie della malattia si osservano principalmente in primavera e in autunno, che è associata alle dinamiche stagionali del tasso di natalità dei gattini.
Infezione. Avviene principalmente per contatto e per goccioline trasportate dall'aria; non è possibile escludere la trasmissione trasmissibile dell'agente infettivo.
Il periodo di incubazione delle malattie respiratorie infettive dei gatti è determinato dalle caratteristiche dell'agente patogeno specifico. Quindi, con l'infezione da virus dell'herpes nei gatti, di solito dura 2-6 giorni, con l'infezione da calicivirus - da 3 a 19 giorni.
Patogenesi. A causa del fatto che le malattie respiratorie infettive dei gatti hanno una natura polietiologica e multifattoriale, le forme cliniche e le dinamiche della manifestazione delle malattie sono molto diverse. Ad esempio, la durata dei vari stadi della malattia (incubazione, prodromica, clinica) dipende dal tipo e dalla virulenza di specifici agenti patogeni, nonché dalla resistenza generale e dall’immunoreattività dell’organismo dell’animale.
Il principale sito di penetrazione degli agenti patogeni è l'epitelio delle mucose del tratto respiratorio superiore, della cavità orale e della congiuntiva degli occhi. Inoltre, il virus dell’herpes felino è tropicale rispetto alle parti in crescita dello scheletro, compresi i turbinati. Il calicivirus felino è tropicale rispetto al tessuto polmonare e alle articolazioni, quindi la combinazione di polmonite e zoppia è un importante segno diagnostico di infezione da calicivirus.
Sintomi Le malattie respiratorie infettive dei gatti, a causa della varietà di agenti patogeni, possono manifestarsi in forme iperacuta, acuta, subacuta, cronica e latente (latente).
Un decorso iperacuto si osserva più spesso con l'infezione virale dell'herpes nei gattini di età compresa tra 1 settimana e 1,5 mesi. La malattia inizia improvvisamente: a causa del grave gonfiore della mucosa del rinofaringe e della cavità orale, i gattini non riescono a succhiare il latte dalla madre e muoiono entro 24 ore. Altri sintomi clinici non sono espressi.
Infezione virale da herpes (sintomi). Nella forma acuta, i primi sintomi della malattia sono depressione, anoressia, aumento della temperatura corporea a 40-41 ° C, dolore addominale pronunciato, flatulenza, gonfiore delle mucose del rinofaringe e della cavità orale e starnuti frequenti. Successivamente si notano abbondanti secrezioni dal naso e dagli occhi, forte sbavatura, mancanza di respiro e tosse. Inoltre, si osserva spesso una congiuntivite sierosa e purulenta acuta, complicata dalla cheratite ulcerosa.
A volte si sviluppano ulcere anche sulla lingua, sul palato molle e sul palato duro dell'animale. Il rifiuto forzato e prolungato di cibo e acqua che si verifica per questo motivo porta solitamente all'esaurimento, alla disidratazione e alla morte.
Con un decorso favorevole della malattia, il recupero avviene in 1-2 settimane, tuttavia, la necrosi delle mucose della cavità nasale può causare rinite cronica e sinusite. Nel caso dello sviluppo di infezioni associate (virus dell'herpes e calicivirus, nonché batterici) o del verificarsi di infezioni secondarie, di norma si osserva un decorso sfavorevole della malattia, lo sviluppo di bronchite e broncopolmonite, spesso con una esito fatale.
A decorso subacuto le malattie negli animali presentano segni clinici simili, ma sono meno pronunciati e si sviluppano per un periodo di tempo più lungo - 2-3 settimane.
Decorso cronico le malattie negli animali si notano spesso in presenza di infezioni batteriche secondarie che causano bronchite indolente, polmonite o broncopolmonite. Con questa forma della malattia si osserva solitamente un trasporto virale prolungato. È caratteristico che la diffusione del virus non inizi immediatamente, ma dopo che l'animale ha subito un grave disagio (trasporto del gatto in un nuovo luogo, in una clinica veterinaria, cambio di proprietario, uso di farmaci ormonali, ecc.).
Forma nascosta (latente). la malattia non si manifesta con segni clinici, tuttavia, con appositi esami di laboratorio è possibile determinare alterazioni infettive e patologiche e la presenza di reazioni protettive e immunologiche caratteristiche di questa infezione virale dell'herpes. Anche i gatti con una forma latente della malattia sono portatori del virus.
Infezione da calicivirus (sintomi). Il decorso acuto della malattia è caratterizzato da depressione, febbre a breve termine, anoressia, gonfiore delle mucose delle cavità nasali e orali, nonché secrezione dal naso e dagli occhi (meno abbondante rispetto all'infezione virale dell'herpes). Sono comuni starnuti, tosse e lieve congiuntivite. Il sintomo diagnostico più importante è l'ulcerazione sul setto nasale e nella cavità orale: sulla lingua, sul palato molle e duro, sulle labbra. La malattia dura 1-2 settimane e solitamente termina con la guarigione in assenza di infezioni secondarie.
Nei gattini l'infezione da calicivirus ha spesso un decorso sfavorevole e si complica con lo sviluppo di infezioni batteriche secondarie che causano gastroenterite, bronchite e broncopolmonite. Ciò si osserva principalmente nei gattini di età compresa tra 1 e 3 mesi, quando termina la loro immunità colostrale.
Il decorso subacuto è caratterizzato da un lento sviluppo dei segni clinici di cui sopra e si osserva principalmente negli animali indeboliti ed emaciati. La malattia dura 2-4 settimane e in caso di condizioni immunosoppressive può diventare cronica.
Il decorso cronico della malattia, come con l'infezione virale dell'herpes, si osserva principalmente con lo sviluppo di infezioni batteriche secondarie. Questa forma è pericolosa perché gli animali malati sono portatori a lungo termine del virus.
Diagnosi. A causa della varietà dei segni clinici delle varie forme di malattie respiratorie infettive dei gatti, una diagnosi accurata viene stabilita sulla base di test di laboratorio. In questo caso, è necessario identificare il principale agente eziologico della malattia (per determinare il principale fattore eziologico), poiché questo è di fondamentale importanza per l'ulteriore sviluppo di misure efficaci per il trattamento e la prevenzione della malattia.
Nella diagnosi differenziale, è possibile effettuare una diagnosi differenziale preliminare (clinica) sulla base delle caratteristiche comparative dei principali sintomi delle malattie respiratorie infettive sopra elencate (vedere Tabella 4).
La prognosi dipende dal tipo di agente patogeno, dalla sua virulenza, dallo stato del sistema immunitario dell’animale e dalla forma della malattia. In decorso iperacuto la prognosi è solitamente letale; in decorso acuto e subacuto è favorevole o sfavorevole; nel caso di infezioni miste la prognosi è spesso fatale. Nella forma cronica, la prognosi a lungo termine è solitamente sfavorevole. La mortalità nell'infezione acuta da virus dell'herpes nei gattini è del 20-30% e in caso di infezione da virus dell'herpes - circa il 30%.
Trattamento. Per le malattie respiratorie infettive dei gatti viene effettuata una terapia etiotropica, patogenetica e sintomatica complessa individuale.
Terapia etiotropica. Come trattamenti specifici all'inizio della malattia, si consiglia di utilizzare le globuline polivalenti Vitafel e Globfel contro la panleucopenia, la rinotracheite infettiva, il calicivirus e la clamidia nei gatti, nonché i corrispondenti sieri iperimmune, da utilizzare 2-3 volte.
Terapia patogenetica. Un buon risultato si ottiene utilizzando il metodo della paraimmunizzazione. A questo scopo, gli immunomodulatori vegetan (vitan) e poliossidonio vengono utilizzati sotto forma di iniezioni sottocutanee o intramuscolari in una dose di 1 mg per un animale adulto. Corso del trattamento: iniezioni giornaliere per i primi 3 giorni, quindi a giorni alterni per 7-10 giorni.
In caso di decorso sfavorevole della malattia è importante fornire un supporto completo ai più importanti sistemi fisiologici del corpo. Si consiglia di utilizzare iniezioni sottocutanee di soluzioni di sulfocanfocaina alla dose di 0,3-0,5 ml (per un animale adulto) 1-2 volte al giorno durante l'intero ciclo di trattamento. Un buon effetto si osserva anche con la somministrazione sottocutanea della seguente soluzione: 1 ml di soluzione Essentiale Forte (per iniezione endovenosa) per 10 ml di soluzione di glucosio al 5% o 10 ml di soluzione salina (per iniezione).
Per sopprimere le infezioni secondarie si raccomandano iniezioni intramuscolari di antibiotici ad ampio spettro. In caso di disidratazione del corpo, viene effettuata una reidratazione intensiva per ripristinare l'equilibrio elettrolitico: somministrazione sottocutanea e (o) endovenosa di soluzioni isotoniche di Ringer - lattato, trisoli, quadrosoli, ecc., nonché somministrazione rettale di soluzioni terapeutiche e nutrizionali .
Per accelerare la guarigione delle erosioni e delle ulcere causate da infezioni virali, si consiglia di utilizzare iniezioni intramuscolari di solcoseryl (Actovegin). Corso del trattamento: iniezioni giornaliere per 10 giorni. Per il trattamento della cheratite ulcerosa alcuni autori consigliano l'utilizzo di una soluzione oftalmica allo 0,1% di 5-iodo-deossiuridina. Corso del trattamento: 4-5 volte al giorno per 5-7 giorni.
...Documenti simili
Malattie infettive particolarmente pericolose: influenza, antrace, epatite virale, encefalite trasmessa da zecche, AIDS, tularemia. La comparsa di epidemie e classificazione delle malattie infettive in base al meccanismo di trasmissione. Distruzione di agenti patogeni e vettori di malattie.
presentazione, aggiunta il 22/06/2015
presentazione, aggiunta il 28/03/2015
La necessità di individuare precocemente pericolose infezioni di massa in fase ospedaliera nel periodo iniziale della malattia. I principali tipi di malattie infettive dell'uomo, delle piante e degli animali. Studio della dinamica della morbilità nella Repubblica di Khakassia per il periodo 2005-2010.
lavoro del corso, aggiunto il 07/09/2011
Malattie infettive di cui una persona di solito soffre durante l'infanzia. Trattamento di pazienti con rosolia. Parotite epidemica (parotite, dietro le orecchie). Mezzi di prevenzione della varicella. Difterite tossica dell'orofaringe. Diffusione dell'infezione tramite goccioline trasportate dall'aria.
abstract, aggiunto il 17/01/2011
Il concetto e la natura delle moderne infezioni nosocomiali (ICA): eziologia, principali agenti patogeni, metodi di prevenzione. Infezione da HIV: tipologie, morfologia del patogeno, vie di trasmissione, precauzioni. Epatite parenterale (virale) e loro struttura.
Malattie infettive: rosolia, morbillo, varicella, infezioni intestinali, meningite. Patogeni, epidemiologia, quadro clinico, trattamento, complicanze, diagnostica di laboratorio. Misure relative ai pazienti e alle persone di contatto. Ricovero ospedaliero. Infezione.
lavoro del corso, aggiunto il 29.09.2008
Malattie infettive e invasive comuni all'uomo e agli animali. Antrace, rabbia: segni, misure di controllo. Leptospirosi: epizootologia, immunità, decorso e sintomi negli animali. Caratteristiche della prevenzione della tularemia. Storia dello studio di Yersinia.
test, aggiunto il 04/12/2011
lavoro scientifico, aggiunto il 12/12/2013
La schizofrenia è una malattia mentale con tendenza alla cronicizzazione. Influenze ambientali che influenzano il rischio di malattie. Infezione virale. Trasmissione della malattia attraverso animali malati infetti. La ricerca attuale nell'infanzia.
presentazione, aggiunta il 21/03/2014
Le malattie sessualmente trasmissibili sono malattie infettive del sistema genito-urinario femminile e maschile, che si trasmettono attraverso il contatto sessuale. Principali malattie sessualmente trasmissibili. Sintomi di malattie sessualmente trasmissibili. Conseguenze e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
Tracheobronchite infettiva– una malattia respiratoria contagiosa che si manifesta con la tosse.
Uno degli agenti causali della tracheobronchite infettiva nei cani può essere l'adenovirus di tipo 1-2. La tracheobronchite infettiva si verifica più spesso nei luoghi in cui si riuniscono gli animali (aree di passaggio per animali, negozi di animali, laboratori di ricerca). La malattia si manifesta a qualsiasi età, ma è particolarmente grave nei cuccioli di età compresa tra 6 settimane e 6 mesi. Anomalie congenite dell'apparato respiratorio, bronchite cronica e bronchiectasie predispongono alla malattia.


Dermatofitosi canina e nei gatti è solitamente causata da funghi patogeni del genere Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes. Questa infezione è contagiosa per le persone e altri animali.
L'infezione avviene attraverso gli animali malati (lana, scaglie), l'ambiente (infetto da funghi) e gli oggetti per la cura (lettiera, ciotola, spazzola).
Le fonti di infezione (serbatoi) sono solitamente (Microsporum canis), (Trichophyton mentagrophytes) e il suolo (Microsporum gypseum).
L’immunità cellulo-mediata è un anello importante nel meccanismo di difesa contro i funghi patogeni.

Tutti conoscono l'antica incisione, che raffigura personaggi del penultimo secolo che camminano con un bassotto, la cui metà posteriore del corpo rotola su un carro. La causa di questo fenomeno è l'ernia del disco, una malattia molto diffusa in alcune razze di cani.

Displasia(Greco dis - deviazione dalla norma, plasis - formazione, educazione; displasia - disturbo dello sviluppo). La displasia dell'anca (HJ) è un difetto anatomico di sottosviluppo dell'acetabolo, che comporta il rischio di compromissione delle funzioni muscoloscheletriche degli arti posteriori. Questa malattia ha una natura multipla, nello sviluppo della quale giocano un ruolo importante: la rapida crescita durante l'infanzia e l'adolescenza dell'animale, nonché l'alimentazione “eccessiva”. Oltre alla vera displasia, questi fattori possono portare a un'interruzione secondaria della formazione della parte superiore della coscia e, di conseguenza, alla displasia dell'anca. Inoltre, i cambiamenti nella struttura anatomica delle vertebre lombari portano alla displasia secondaria dell'anca. Va notato che i cambiamenti nella colonna vertebrale non portano alla displasia dell'anca anatomica, ma "funzionale" con conseguenze caratteristiche della vera displasia dell'anca.


Colpoè una malattia che si colloca al terzo posto tra le cause più comuni di morte umana. Fortunatamente, gli animali non sono inclini all’ictus come gli esseri umani. e raramente soffrono di ipertensione, non sono soggetti alla formazione di placche di colesterolo nei vasi sanguigni, non fumano né bevono alcolici. Cioè, non presentano i principali fattori di rischio per un ridotto afflusso di sangue al cervello. Nella stragrande maggioranza dei casi, i sintomi di una malattia completamente diversa chiamata sindrome vestibolare periferica vengono scambiati per un ictus. I sintomi di questa malattia sono causati da un danno all'organo dell'equilibrio: il labirinto della coclea e/o l'VIII paio di nervi cranici. Queste strutture sono spesso colpite da malattie infiammatorie dell'orecchio. Pertanto, la prima cosa che dovrebbe fare un veterinario è esaminare il canale uditivo esterno.
I virus animali sono generalmente elicoidali o icosaedrici, possono esserlo scoperto("nudo") o conchiglia. Un virus non rivestito ha solo un capside, come un fago. Un virus avvolto ha anche un capside, ma oltre ad esso c'è anche un involucro lipidico, costituito da parte della membrana della cellula ospite, che il virus cattura quando lascia la cellula.
Il genoma virale determina la produzione di specifiche glicoproteine che vengono inserite nella membrana. Il capside del virione si attacca alle estremità di queste glicoproteine sul lato citoplasmatico della membrana, facendo sì che parte della membrana si leghi al virione. In questo "involucro" può staccarsi dalla membrana cellulare in un processo chiamato gemmazione senza lasciare un buco.
Il virione si lega a un recettore specifico sulla membrana cellulare per infettare la cellula. Il recettore, come la chiave di una serratura, si inserisce nel capside di un virus scoperto o nella glicoproteina dell’involucro lipidico di un virus avvolto. Nella cellula, il capside, o involucro, viene rimosso e rilascia il genoma virale, che può essere costituito da DNA o RNA, a filamento singolo o doppio, lineare o circolare (se si tratta di DNA, poiché i genomi virali sono costituiti da RNA circolare sono sconosciuti). I genomi virali, costituiti da DNA, si replicano nel nucleo della cellula ospite, mentre i genomi, costituiti da RNA, rimangono nel citoplasma della cellula.
I virus causano quattro tipi di infezione negli animali:
1. Acuto, O litico. I virus subiscono un ciclo litico (descritto sopra nella sezione sui fagi) e uccidono rapidamente la cellula ospite, provocandone la distruzione e il rilascio di virioni progenie.
2. Latente. Corrisponde al ciclo lisogenico dei batteriofagi. Il virus infetta una cellula ma rimane inattivo finché non si verificano determinate condizioni.
3. Persistente. Nuovi virioni vengono rilasciati lentamente dalla superficie cellulare, ma la cellula rimane viva. Di conseguenza, vengono prodotti virus pacchettizzati.
4. Trasformativo. La cellula ospite non solo produce virioni, ma si trasforma anche da normale a cancerosa grazie all'inserimento di un oncogene portato dal virus.
I virus a DNA o RNA hanno percorsi diversi di replicazione, trascrizione e traduzione quando infettano le cellule animali.
I tipici virus contenenti DNA a doppio filamento si attaccano alla superficie della cellula, penetrano all'interno e quindi rilasciano il capside (un processo chiamato disimballaggio). Gli enzimi della cellula ospite replicano il DNA virale e lo trascrivono in mRNA, che i ribosomi della cellula ospite traducono in proteine del capside virale o (a volte) in enzimi che favoriscono la replicazione del DNA virale rispetto alla replicazione del DNA proprio della cellula ospite. Le proteine del capside - capsomeri - formano un capside attorno alla replicazione del DNA virale e vengono poi rilasciate in seguito alla distruzione o alla gemmazione cellulare (quando vengono prodotti i vibrioni avvolti dai lipidi descritti sopra). Il DNA a filamento singolo del virus segue lo stesso percorso, solo il secondo filamento viene prima costruito dai nucleotidi della cellula e solo successivamente il DNA a doppio filamento risultante viene trascritto e tradotto.
Il ciclo di vita dei virus contenenti RNA è più complesso del ciclo di vita dei virus contenenti DNA. La maggior parte delle cellule ospiti non può replicare o riparare l’RNA perché la cellula non possiede gli enzimi necessari per farlo. Di conseguenza, i virus contenenti RNA sono più suscettibili alla mutazione. I genomi virali, composti da RNA, devono includere geni che codificano per enzimi per la propria replicazione, oppure i virus devono già portare con sé questi enzimi quando entrano nella cellula ospite.
I genomi virali, costituiti da RNA a filamento singolo, sono etichettati (+) o (-). Filamento di RNA (+). funge da mRNA nella cellula ospite, codificando (come minimo) le proteine del capside e gli enzimi per la replicazione dell'RNA virale. Filamento di RNA (-).è complementare al filamento di mRNA che codifica per tutte queste proteine e deve portare con sé un enzima in grado di sintetizzare il filamento (+) lungo il filamento (-), dopodiché inizia la sintesi delle proteine e degli enzimi necessari.
I genomi di RNA a doppio filamento si replicano più o meno in modo simile ai genomi di DNA a doppio filamento utilizzando un enzima chiamato Replica dell'RNA. E infine, i retrovirus portano con sé trascrittasi inversa- un enzima che copia l'RNA dei loro genomi nel DNA. Il DNA risultante può essere integrato nel genoma della cellula ospite o utilizzato per la trascrizione. Come osservato nel Capitolo 8, alcuni retrovirus trasportano oncogeni che trasformano le cellule ospiti in cellule tumorali. Un altro esempio di retrovirus che inseriscono geni pericolosi nel genoma dell'ospite è il virus HIV-1, che causa l'AIDS. È il virus più complesso esistente perché contiene almeno sei geni aggiuntivi.